Il Kōan, l’enigma Zen
Scritto da -Articolerò questo mio contributo1 sul kōan Zen in tre punti: 1) che cos’è il kōan; 2) come si svolge lo studio del kōan e il ruolo del maestro; 3) (due parole sul) kōan “Mu”.
1) Che cos’è il Kōan
Originariamente, cioè durante la dinastia T’ang (che regnò in Cina dal settimo al decimo secolo d.C.), il termine kōan aveva natura giuridica rappresentando un caso legale al quale riferirsi per formulare giudizi in vertenze sostanzialmente simili. Come termine tecnico Zen, lo si inizia ad usare nella tarda dinastia Sung (undicesimo/tredicesimo secolo d.C.), con il significato di “tema o problema per la meditazione”. Vi sono stati due momenti importanti nella standardizzazione della pratica: nell’undicesimo secolo, con il maestro Daie, e nel diciottesimo secolo, con il maestro Hakuin, il quale classificò i kōan in alcune categorie fondamentali a seconda del livello di maturazione spirituale del discepolo. Nel 1955, a New York, il maestro Miura tenne una serie di conferenze sullo studio del kōan, approfondendo la classificazione in categorie di Hakuin (che sono: Kenshō kōan, Hossin kōan, Kikan kōan, Nanto kōan, Goi kōan).2
Nel corso dei secoli sono state compilate diverse raccolte di kōan3, alle quali ricorrono i maestri della scuola Rinzai per scegliere quale kōan dare in studio al discepolo.
Costruito artificialmente quale tema per la meditazione, il kōan è costituito, per lo più, da un brevissimo scambio di battute tra un discepolo e un maestro; il discepolo pone una domanda su un aspetto della visione Zen e il maestro risponde con una frase oscura, con un grido, ripetendo la domanda oppure compiendo un’azione (accenna a un oggetto lì presente, lascia immediatamente il luogo in cui i due si trovano senza rispondere, ecc.). Capita anche che il kōan sia composto da una sola affermazione del maestro (o una sua domanda a chi gli è attorno), da un breve brano tratto da un sutra o da un testo classico del buddhismo, o da aneddoti relativi a particolari momenti della vita dei maestri. Precedono il kōan, o lo seguono, suggerimenti di altri maestri, note, osservazioni, commenti, poesie che mirano ad arricchire di contenuti, a espandere, o a frastagliare, il brevissimo dialogo. Il protagonista è sempre uno specifico maestro, un Patriarca dell’antichità4. Gli fanno da spalla uno o più monaci, o in alcuni casi figure socialmente importanti dell’epoca, come l’Imperatore o un Ministro. La scena dove si svolge l’azione non è solitamente descritta, anche se si può ragionevolmente pensare che sia all’interno di un monastero o durante un viaggio del maestro.
Per quanto possa essere poliforme il loro contenuto, tutti i kōan mostrano la Realtà fondamentale così come la vede lo Zen e sono concepiti in modo da confondere il pensiero discorsivo e rendere impossibile qualsiasi approccio razionale, in modo da “(ri)svegliare” nel discepolo uno stato di realizzazione spirituale che coinvolga l’intero suo essere, corpo e mente.
Cruciale è il primo kōan che viene dato al discepolo e che “apre” la “porta senza porta” dello Zen. L’improvvisa esperienza che porta alla comprensione è chiamata Kenshō5: è la visione della Natura di Buddha, l’irruzione improvvisa del Tutto nella Parte e la simultanea scomparsa di entrambi come entità auto sussistenti.
Secondo la Scuola Rinzai, non c’è Zen senza Kenshō. La preparazione del terreno dal quale misteriosamente scaturisce l’evento decisivo è affidata ai kōan:
- “Qual è il suono di una sola mano?” di Hakuin;
- il “Mu” di Joshū: Si tratta del Caso 1 del Mumonkan, il cui testo recita: “Una volta un monaco chiese al maestro Joshū: “Un cane ha la Natura di Buddha, o no?”. Joshū rispose: “Mu!”.
- “Il Volto Originario” di Hui Neng: Hui Neng disse a un discepolo: “Non pensare al bene, non pensare al male, ma vedi com’è, in questo momento, il tuo Volto Originario, quello che avesti ancor prima che nascessero i tuoi genitori”.
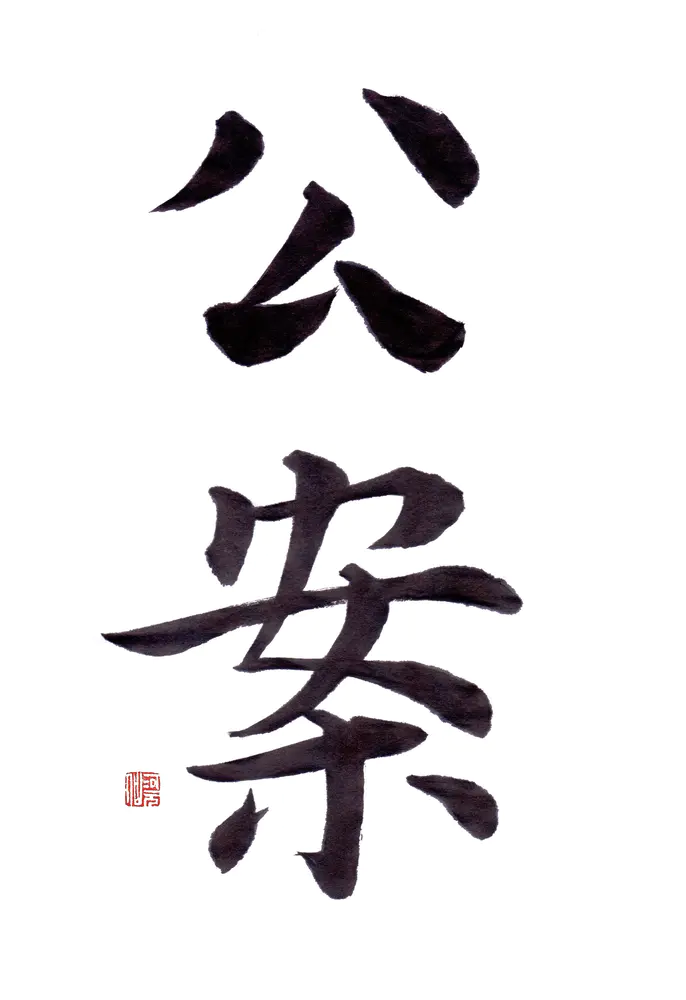
Calligrafia di Bruno Riva (www.shodo.it)
Il praticante deve sperimentare l’assoluta Vacuità, vedere l’abisso metafisico e insieme sentirsi – per usare un’espressione del maestro Kanzan – come “un grande Tutto illuminante, infinitamente lucido e sereno”.6
L’Interiore del ricercatore e l’Esteriore del mondo improvvisamente abbandonano la loro opacità ontologica e si mostrano totalmente trasparenti, simultaneamente compenetrati, fusi e distinti.
La straordinarietà dell’esperienza del Kenshō deriva anche dal suo avvenire senza alcun sostegno dall’esterno, e la cui ultima goccia scatenante è, da sempre, un fatto di per sé insignificante (il suono prodotto da un sassolino che batte contro qualcosa, il cadere di una foglia, la lettura di un passo di un libro, ecc.) ma dagli immensi effetti esistenziali.
Il maestro Hakuin raccontò che al momento della comprensione gli parve che tutto l’universo intorno a lui si congelasse improvvisamente per poi immediatamente esplodere rivelando la reale natura di ciò che siamo.
Il maestro Hsiang Yen così poetizzò (gāthā) la sua esperienza di illuminazione:7
Il suono secco di una pietra che colpisce il bambù!
E tutto quel che avevo imparato fu immediatamente dimenticato.
Non vi è stato alcun bisogno di addestramento e disciplina.
Con ogni azione e movimento della vita quotidiana
Io manifesto la Via eterna.
Mai più cadrò in una trappola nascosta.
Non lasciando alcuna traccia dietro di me andrò ovunque.
2) Come si svolge lo studio del kōan e il ruolo del maestro
Il kōan può esser chiesto dal discepolo al maestro solo dopo un adeguato periodo di pratica di meditazione che ha anche lo scopo di verificare la sua reale motivazione. Il maestro può accettare la richiesta oppure invitare il discepolo a continuare nella pratica di base della meditazione.
Ecco un piccolo racconto/kōan che rappresenta bene una situazione nella quale il maestro invita il discepolo a continuare la pratica:
“Un maestro Zen disse addio al discepolo. Gli disse di andare nel mondo a raccontare agli altri tutto ciò che gli aveva insegnato. Al momento della partenza il maestro disse: “E quando attraversi il fiume, fai attenzione a non bagnarti i piedi”. Il discepolo fu colto alla sprovvista e iniziò ad agitarsi. Attraversare il fiume senza bagnarsi i piedi? Se i piedi non devono bagnarsi, meglio evitare il fiume! Il maestro disse: “È meglio che tu ancora non vada. Se non hai capito questa piccola questione, il momento della tua partenza non è ancora arrivato”. Il discepolo chiese spiegazioni. “Non è qualcosa che si può spiegare” disse il maestro. “Ricomincia dalle tue meditazioni. Fai ancora pratica dell’essere testimone, perché questo è il suo significato”.8
Se il maestro ritiene che il discepolo sia “pronto” darà il kōan nel corso del primo, formale incontro one to one, dopo aver precisato le regole base sia della pratica sia del comportamento (riservatezza assoluta, rapporto esclusivo con il maestro, ecc.). Niente di scritto, ovviamente, ma la “contrattualizzazione” del legame è scolpita nel granito spirituale. Da quel momento in poi, il discepolo dovrà andare dal maestro ogni qual volta è stabilito dalle prassi del luogo di pratica (in genere, tre o quattro volte al giorno durante i ritiri), seguendo un preciso rituale di entrata, e poi di uscita, dalla piccola saletta dove si svolge il sanzen, cioè l’incontro con il maestro.
Nelle prime fasi dello studio il praticante non può che affidarsi alla razionalità, cercando un “significato”, un “senso” al kōan, ma presto si fa chiaro che non può essere l’intelletto a rispondere. Sarà un’intuizione della saggezza-prajna a risolvere la questione. Il kōan va messo nella pancia e lasciato lì a “bollire” a fuoco lento (dicono i maestri: “chiedi alla pancia”, “pensa con la pancia”, “vedi e senti con la pancia”), accompagnando, come un basso continuo, la vita quotidiana del praticante, il quale lo “rimasticherà, sino a che casca il dente” (R. Barthes).
Esaurire la benzina della mente non è facile; deve essere abbandonata ogni forma di pensiero abituale e ogni possibile comprensione intellettuale, il che provoca uno shock psicologico che tutti i praticanti, prima o poi, devono vivere e superare. Quando il corpo-mente è giunto a maturazione (paradossalmente, quando è pronto all’esperienza della propria nullificazione!), il motore spirituale si accende e la dimostrazione salta fuori con una immediatezza disarmante.
Per quanto oscuro appaia il kōan, la sua dimostrazione (perché ieri, come oggi, come domani, il kōan non si spiega, ma si mostra) dovrà essere semplice, chiara, diretta, comprensibile anche per un bambino, e tutto ciò che serve per darla è già presente nella piccola stanza dove si svolge l’incontro tra il maestro e il discepolo. Il principio fondamentale su cui si incardina la pratica del kōan è questo: nella stanza di sanzen Tu (praticante) sei la risposta, e non ti manca mai niente per esprimerla, anche se ti fosse chiesto di mettere la Luna sulla mano!

Pubblico dominio, Wikimedia Commons.
Il maestro disse: “Finché non vedrai la montagna, non vedrai la verità.”
www.visioneolistica.it/la-montagna-koan
Acquisire il corretto approccio alla pratica del kōan richiede tempo: nessuna competizione con gli altri praticanti che potrebbero avere lo stesso kōan e, ancor più importante, nessuna vergogna, timore o paura di non essere all’altezza. Le cattedre, le lavagne e i gessetti, i professori e gli studenti, i registri e i voti, chi è bravo e chi non lo è, in altre parole “la commedia umana”, rimangono fuori dalla stanza del sanzen.
Ci sono soltanto due Esseri che si avvicinano e che, come due legni strofinati insieme da mani sapienti, possono generare il fuoco della verità. Uno dei due lo ha già acceso, l’altro ci sta provando. Si entra a sanzen con concentrazione, si ricorda al maestro qual è il kōan che si sta praticando, e immediatamente si mostra la propria verità, si esprime la propria risposta-verità.
Ogni volta è la prima volta: gli specchi si avvicinano e accade quello che accade, sempre un originale, ogni sanzen è un originale, è unico, foss’anche il milionesimo che ognuno vive con il proprio maestro.
Il maestro – il quale, naturalmente, ha già praticato, al tempo della sua formazione, i kōan che dà in studio ai propri discepoli – svolge un ruolo cruciale nel processo di crescita spirituale del discepolo ma non può nulla riguardo alla sua illuminazione; inizialmente lo fa brancolare all’interno di un labirinto buio senza dargli alcuna indicazione; poi, quando muove i primi passi sul sentiero della Via, quando le prime nebbie della sua mente cominciano a diradarsi, lo sostiene, lo corregge se prende una via errata, lo guida fino al confine estremo; ma giunti insieme sull’orlo dell’abisso, il balzo nella grande fornace del Nulla (l’ottava Stazione dei Tori Zen) può essere fatto solo dal discepolo che dovrà cercare al buio una cosa che non c’è, e trovarla. Troverà, come insegna la dottrina Hua-Yen: “Un reticolo di gemme, ognuna rispecchia tutte le altre e così via all’infinito, senza che mai si possa afferrare un nucleo primario d’irradiazione… una ripetizione senza origine, un evento senza causa, una memoria senza persona, una parola senza ormeggi”.9
Così Ling-yü descrive la sua realizzazione:10
Per trent’anni ho ricercato il sé originario.
Quante volte si sono alternati primavera e autunno!
D’un tratto ho visto il pesco in fiore.
Adesso non dubito più.
3) (due parole sul) Kōan “Mu”
Il celebre kōan “Mu” fa parte della ristrettissima categoria dei kōan che i maestri Rinzai danno in studio ai propri discepoli affinché possano realizzare la loro vera natura (Kenshō).

Calligrafia di Bruno Riva (www.shodo.it)
Per la sua assoluta inafferrabilità è considerato uno strumento tra i più efficaci per costringere la mente del praticante ad andare oltre l’opposizione affermazione/negazione (Mu significa No, ma in altra occasione, alla stessa domanda, la risposta di Joshū fu U che significa Sì), sciogliendo la sua soggettività nel Mu, diventando Mu.
Come già detto sopra il kōan recita così:
Una volta un monaco chiese al maestro Joshū: “Un cane ha la Natura di Buddha, o no?”. Joshū rispose: “Mu!”.
Il monaco, in sostanza, fa riferimento alla dottrina Mahayana, secondo la quale la natura-di-Buddha (chiamata anche: Assoluto, Mente, Non-mente, Mente Unica, Mente-Realtà, con significati sostanzialmente equivalenti) è in tutte le cose, e chiede al maestro se anche il cane ce l’ha. Vuol mettere alla prova la realizzazione di Joshū, ma già porre la domanda svela la sua immaturità, confondendo “realizzazione spirituale” e “comprensione intellettuale”. Joshū non cade nell’ingenua trappola e sbriciola immediatamente l’impostazione concettuale che sostiene la domanda del monaco: grida Mu, e lo fa in un modo tale da mostrare la Realtà non-articolata che sta prima della biforcazione Soggetto/Oggetto.
Nello stato assoluto nel quale si trova il maestro nel momento in cui grida Mu, il fatto che il cane abbia o non abbia la natura di Buddha è del tutto irrilevante, anzi, la domanda è totalmente inconsistente.
Il Nulla manifestato dal grido si porta via con sé il monaco, il maestro, il cane, la natura-di-Buddha, la domanda e la risposta (tutte entità separate irrintracciabili nella Realtà Originaria).
La pratica è molto semplice (e, quindi, per la nostra razionalità, complicatissima!): “osservare” il Mu durante la meditazione e, quando possibile, anche durante la vita di tutti i giorni. Quando il corpo-mente del praticante sarà diventato il corpo-mente di Joshū, anche il suo Mu sarà il Mu di Joshū (e sarà accettato dal maestro); accadrà quando non avrà pensato Mu ma sarà stato Mu (e lo potrà mostrare in ogni momento della sua vita futura).
Quando Mu è Mu cadono le strutture spazio-temporali: l’“Ora” è l’“Eterno Ora”, il “Qui” è l’“Ubiquo Qui”.11
Realizzato che il Tutto è Mu come è Mu anche ogni ente che vi sta dentro (dal quark, a lui stesso, all’intero universo), il discepolo comprenderà anche la verità fondamentale dello Zen così come espressa mirabilmente dal maestro Shogaku (1091-1157):
La Realtà non ha alcun proprio aspetto definito; si rivela conformemente alle cose. La Saggezza non ha alcuna propria conoscenza definita; si illumina in risposta alle situazioni. Guarda! Il verde bambù è così serenamente verde; il fiore giallo è così profusamente giallo! Prendi qualsiasi cosa vuoi, e guarda! In ogni singola cosa Esso si manifesta così apertamente”.12
Note alle calligrafie Kōan e Mu
Kōan 公 案 - Scritto nella forma regolare 楷書 kǎishū / kaisho e nello stile di Ōuyáng Xún 歐陽詢, ma da caratteri presi dalla sua celebre "Iscrizione della fonte del Palazzo nove volte perfetto" 九成宮醴泉銘 (Jiǔ chénggōng lǐquán míng), opera incisa su stele che da molti critici e calligrafi delle epoche successive fu considerata il maggiore modello di kaishu 楷書. Incisa nel 632 partendo dalla calligrafia autografa di Ōuyáng Xún 歐陽詢, consiste in un testo redatto dal Primo ministro Wei Zheng 魏徵 (580-643) che descrive la visita dell'imperatore Taizong 大宗 (598-649) a Línyóu 麟游, nella provincia dello Shaanxi 陝西, dove aveva fatto ricostruire nel 631 il palazzo estivo dei sovrani Suí 隋. ↩︎
Mu 無 - Scritto nella forma regolare 楷書 kǎishū / kaishoè e nello stile di Ōuyáng Xún 歐陽詢 (557-641). Il modello è estratto da un calco del Sutra del cuore 般若波羅蜜多心經 ricavato da una matrice in pietra incisa molto probabilmente dopo la sua morte con caratteri di scrittura copiati da altre sue opere. ↩︎
Bibliografia
Massimo Shidō Squilloni, (Firenze, 1955; web: www.massimoshido.it; mail: ), vive a Fiesole e ha lavorato per molti anni nel mondo della finanza. Ha studiato lettere e psicologia. Nel 1987 ha iniziato la pratica dello Zen Rinzai con il maestro Engaku Taino; è stato ordinato monaco nel 2001 e nominato maestro di Dharma nel 2006. È il direttore spirituale del centro Zenshinkai di Pisa e segue i centri di Genova e Sanremo. Ha pubblicato: Intorno allo Zen (2015); con Francesco Martinelli e Pietro Giorgio Chūsei Zendrini, Inghiottendo la coda del Bue (2019); Zenshin roku – I koan del maestro Zen Engaku Taino (2021).
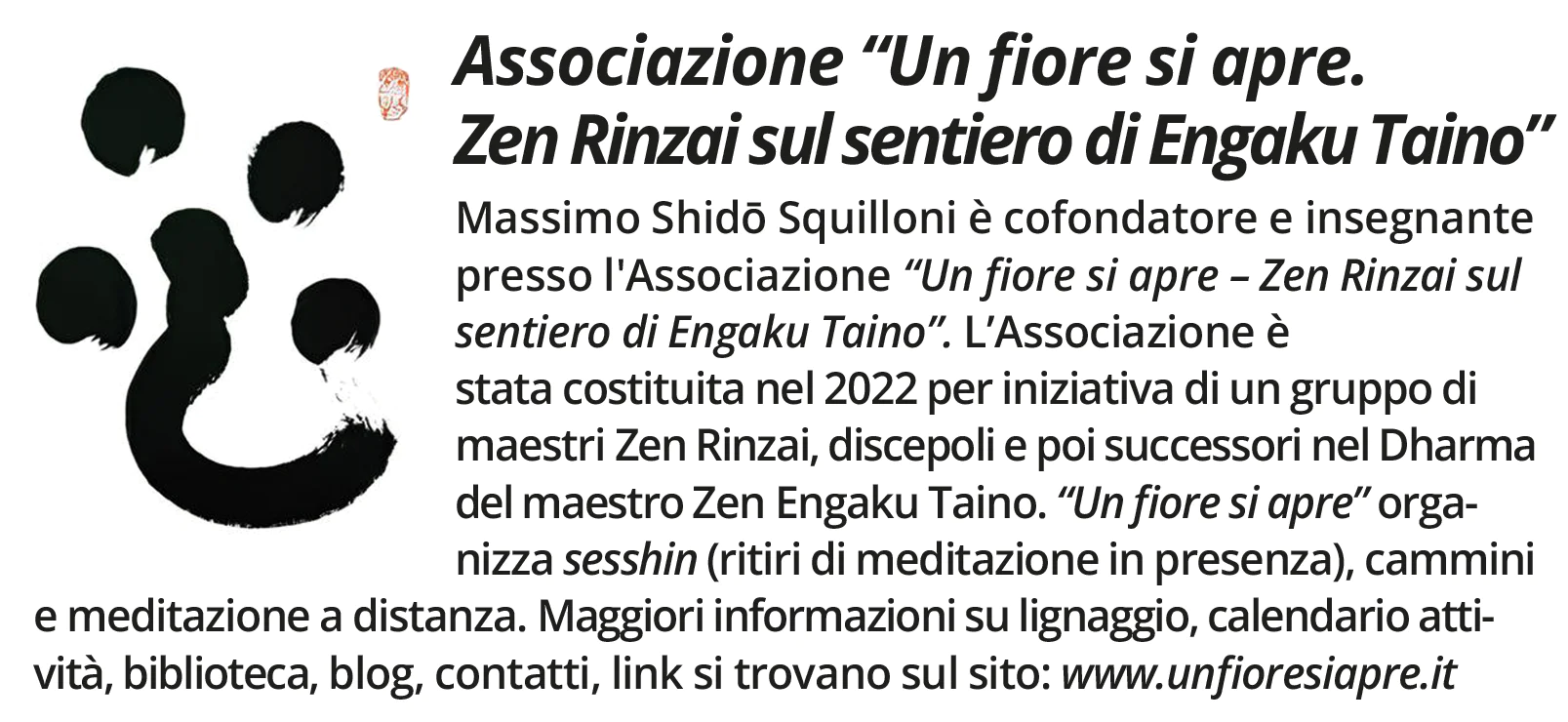
Note
1. Il testo prende a base i saggi di GianGiorgio Pasqualotto e Salvatore Giammusso e la mia introduzione presenti in Massimo Shidō Squilloni, Zenshin roku - I kōan del maestro Engaku Taino, Mimesis Edizioni, Milano 2021. ↩︎
2. Il testo di Miura è disponibile in rete a questo indirizzo: http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/zen/koanmiura.htm ↩︎
3. Tra le principali raccolte: Mumonkan, Hekigan roku, Shōyō-roku, Denkō-roku, Jūjūkinkai. ↩︎
4. Sui kōan moderni creati dal maestro Engaku Taino, vedi nota 1. ↩︎
5. Tradizionalmente, si distinguono due forme di esperienza di illuminazione: il Kenshō e il Satori, le cui differenze sono pressoché impossibili da esplicitare; può aiutare, come spesso nello Zen, l’utilizzo di un ossimoro: il Satori è “un nulla più grande”. ↩︎
6. T. Izutsu, La filosofia del buddhismo Zen, Ubaldini Editore, Roma 1984, p. 186. ↩︎
7. T. Izutsu, La filosofia del buddhismo Zen, cit., p. 188. ↩︎
8. Tratto, con modificazioni formali, dal magazine ”Osho times”, n. 318, maggio 2025. ↩︎
9. R. Barthes, L’impero dei segni, Einaudi, Torino 1984, pp. 92-93. ↩︎
10. T. Izutsu, La filosofia del buddhismo Zen, cit., p. 188. ¶ ↩︎
11. T. Izutsu, La filosofia del buddhismo Zen, cit., p. 61. ↩︎
12. T. Izutsu, La filosofia del buddhismo Zen, cit., p. 53. ¶ ↩︎















