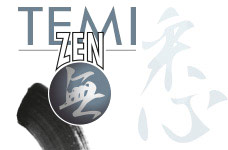Yan Geling
Autrice tra due mondi
Scritto da - Il periodo della Rivoluzione Culturale cinese (1966-1976) è stato vissuto con intensità e ripercussioni diverse dalle varie generazioni che l’hanno attraversata. Tra coloro che maggiormente sono riusciti nell’intento di rielaborazione del proprio vissuto contribuendo alla creazione di una memoria collettiva di quel periodo, ci sono le autrici e gli autori nati negli anni Cinquanta. Molti di loro sono diventati protagonisti della scena letteraria nazionale cinese negli anni Ottanta, un’epoca considerata “d’oro” per la vivacità culturale e intellettuale che caratterizzava la società, anche grazie all’ingresso nel paese di nuove correnti e nuovi stimoli culturali provenienti dall’estero. In quegli anni, dopo il decennio di estrema chiusura e censura della Rivoluzione Culturale, grazie anche ai movimenti culturali e letterari occidentali che finalmente facevano il loro ingresso in Cina, i giovani intellettuali cinesi assaporarono finalmente un certo grado di libertà di espressione e sperimentazione, sia da un punto di vista formale che contenutistico. Molti di loro scelsero di emigrare all’estero, prima per studio e poi per stabilircisi stabilmente, andando a costituire e alimentare quel gruppo di autori e autrici cosiddetto “della diaspora”, che negli anni successivi cercarono di rielaborare il proprio passato e il proprio presente di emigrati, cimentandosi nell’utilizzo di diverse forme narrative e anche di lingue diverse (in particolare l’inglese e il francese).
Nata nel 1959 a Shanghai e cresciuta in una famiglia di intellettuali (il padre era lo scrittore Xiao Ma, la madre adottiva un’attrice) Yan Geling riceve un’ottima istruzione fino allo scoppio della Rivoluzione Culturale (1966-1976). A dodici anni entra a fare parte come ballerina nel Gruppo di lavoratori culturali dell’Esercito di Liberazione a Chengdu, nel Sichuan. Rimane nell’esercito per tredici anni, ricoprendo nell’ultimo periodo il ruolo di inviata di guerra al confine con il Vietnam durante il conflitto sino-vietnamita: sarà proprio questa esperienza di dolore e di morte ad avvicinarla alla scrittura. L’infanzia, la storia familiare e le esperienze di vita durante la Rivoluzione Culturale saranno elementi centrali nella sua produzione letteraria, che tuttavia avrà ampio respiro arrivando a toccare anche altre tematiche storiche, imperniate in particolare su figure femminili quasi archetipiche per il loro vissuto.
Punto di svolta nella vita di Yan Geling è il trasferimento negli Stati Uniti nel 1989, lo stesso anno in cui le rivolte studentesche scuoteranno la società cinese promuovendo nuovi ideali di democrazia e progresso scientifico, incontrando la dura risposta del governo comunista con l’epilogo dei fatti di piazza Tian’anmen. Come molti altri studenti e studentesse cinesi degli anni Ottanta, entusiasti dalla riapertura del Paese e inebriati da quel vento di novità, anche Yan Geling decide di lasciare la Cina per un periodo di studio all’estero, scegliendo come meta il Columbia College, a Chicago, per un master in fiction writing.
Dalla sensibilità e dall’interesse maturati da questa esperienza personale di migrazione, nasceranno alcuni dei personaggi più riusciti di Yan Geling. Forte del vissuto di cultural clash, pregiudizi e incomprensioni che ha caratterizzato la sua personale storia di immigrazione negli Stati Uniti, Yan Geling descrive nei suoi romanzi il dialogo e lo scontro tra la cultura occidentale e orientale che si giocano sulla pelle degli immigrati e delle immigrate cinesi. I due personaggi femminili con cui la scrittrice scandaglia a fondo questo fenomeno, collocandole in due epoche e due Paesi diversi, sono Fusang e Xiaoyu, entrambe testimoni e vittime di questo dialogo/scontro tra culture.
Fusang, protagonista dell’omonimo romanzo (nella versione inglese: The Lost Daughter of Happiness, Hachette Books, 2022), è una giovanissima donna cinese della provincia del Guangdong, rapita e costretta a diventare una prostituta in un bordello della Chinatown di San Francisco del 1860. Figura emblematica della Cina di fine Ottocento, Fusang non ha altre qualità se non quella di incarnare le virtù confuciane su cui si fondava il sistema feudale e patriarcale cinese di quell’epoca, in particolare nell’osservazione rigorosa dei “tre gradi di obbedienza” (san cong 三从) cui la donna doveva sottostare: obbedire al padre come figlia, obbedire al marito una volta sposata, obbedire al figlio o alla famiglia del marito una volta vedova. Fusang aderisce, in un brevissimo lasso di tempo, a tutti e tre i gradi di obbedienza: da giovanissima, obbedisce al padre che la destina in sposa a un uomo di un villaggio vicino, il quale però parte per gli Stati Uniti sull’onda della corsa all’oro, lasciando che il giorno del matrimonio il suo posto venga preso simbolicamente da un gallo, con cui Fusang svolge la cerimonia. In mancanza del marito, Fusang obbedisce diligentemente ai suoceri che prima la sfruttano quasi fosse una serva, e poi orchestrano un piano per venderla come prostituta, convincendola che si recherà in America per raggiungere il marito. Una volta arrivata a San Francisco, Fusang occupa subito il suo posto al bordello, aggiungendosi alla schiera di prostitute per cui gli uomini americani provano attrazione non tanto in virtù della loro bellezza, quanto per il senso di esotismo emanato da queste donne, emblema di quell’orientalismo concettualizzato da Said negli anni Settanta.
Ad attribuire una certa autorevolezza al romanzo sono le fonti storiche consultate che la narratrice porta a sostegno della narrazione, unitamente agli eventi storici di quel periodo che compaiono tra le pagine, a testimoniare il clima di tensione razziale che caratterizzava la società americana in quel periodo. Emblematiche sono due leggi approvate proprio a discapito degli immigrati cinesi in quegli anni: la legge Page del 1875, che vietava l’ingresso di donne cinesi per prostituzione negli Stati Uniti, e, a seguire, il Chinese Exclusion Act del 1882, che vietò per dieci anni l’ingresso agli immigrati cinesi per proteggere il mercato del lavoro americano da manodopera a basso costo.
Questo continuo intrecciarsi di memorie storiche e collettive caratterizza anche la storia di Xiaoyu nell’omonima raccolta di racconti Shaonǚ Xiaoyu (La giovane Xiaoyu) del 1992. Yan Geling si mantiene fedele alle figure femminili e al tema dell’immigrazione, centrali anche in questo racconto, traslandoli negli anni Ottanta: Xiaoyu è una giovane immigrata cinese in Australia che per ottenere il permesso di soggiorno è costretta dal fidanzato Jiang Wei a sposare Mario, un anziano signore australiano di origini italiane. Quello che apparentemente sembrava essere un rapporto legato a uno scambio di interesse (soldi e necessità di cura da una parte, permesso di soggiorno dall’altra) si trasforma col tempo in una relazione di scoperta, amicizia e rispetto, da cui Jiang Wei si sentirà escluso. Su insistenza del fidanzato, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, Xiaoyu sarà costretta a lasciare l’anziano Mario, con il quale, tuttavia, si intuisce essere maturato un sincero affetto, fatto di mutuo sostegno e comprensione. Questo racconto, collocato in apertura alla raccolta dallo stesso titolo, fu il primo a traghettare Yan Geling nel mondo del cinema: Ang Lee, allora regista già premiato con un Oscar per il film Il banchetto di nozze (1993), ne acquista i diritti per farne un film che uscirà nel 1995. Insieme a lui alla sceneggiatura lavora anche Yan Geling, dando così avvio a una carriera nel mondo del cinema che, parimenti a quello della letteratura, incontra largo favore tra il pubblico. Quella con Ang Lee è solo la prima di una lunga serie di collaborazioni con registi di certa fama, sia in Cina che all’estero, e tuttavia il lavoro di sceneggiatura di Yan Geling sembra continuare a essere secondario rispetto a quello di scrittura, dando la sensazione che il cinema sia un mezzo per amplificare e risaltare la trama di romanzi che già alla lettura suggeriscono una narrazione che ben si presta alla trasposizione sul grande schermo.
Nonostante abbia vissuto stabilmente negli Stati Uniti dai primi anni Novanta e, successivamente, abbia seguito il marito Lawrence A. Walker, diplomatico statunitense, nelle sue missioni in altri paesi (Africa ed Europa), nei suoi libri e sceneggiature Yan Geling continua a scrivere di Cina nell’ambito della narrazione storica o autobiografica. Due pellicole che rappresentano bene queste due categorie sono Lettere di uno sconosciuto (2014) e Youth (2017), entrambi diretti da grandi nomi del cinema cinese.
Coming Home è l’adattamento cinematografico dei capitoli finali del romanzo Lu Fan Yanshi (Criminal Lu Yanshi), diretto da Zhang Yimou e con protagonista Gong Li. Il romanzo, uno dei più corposi scritti da Yan Geling, narra la storia dell’intellettuale Lu Yanshi e della sua prigionia in un campo di rieducazione per prigionieri politici durante l’epoca maoista. Etichettato come destrorso durante la campagna anti-destra del 1957, Lu Yanshi è costretto a lasciare la famiglia e a vivere per quasi vent’anni nella provincia del Qinghai, in una prateria all’inizio dell’altopiano sino-tibetano con condizioni di vita estreme. Il film si concentra sulla parte finale del romanzo in cui Lu Yanshi, finalmente riabilitato, può ricongiungersi con la moglie e la figlia, per scoprire però, con amarezza, che il ricongiungimento familiare non sarà idillico come si aspettava: le pressioni e le ritorsioni subite dai cosiddetti destrorsi e dai loro familiari riuscirono a sfaldare intere famiglie e minare nel profondo quei profondi legami interpersonali su cui si fondava la società cinese dell’epoca.
Youth, uscito nel 2017, è invece l’adattamento di una parte del libro più autobiografico di Yan Geling, uscito nel 2005: Suizi Wuyu (La storia di Suizi) è il racconto di formazione della giovane Suizi (nomignolo di Yan Geling) che attraversa tempi e luoghi di una Cina in tumulto, dall’infanzia a Shanghai agli anni nel corpo di ballo dell’Esercito di Liberazione in Sichuan. È proprio quest’ultimo periodo a essere trasposto nel film, concentrandosi sulle dinamiche relazionali dei ragazzi e delle ragazze che gravitano intorno al corpo di ballo. Particolarmente degna di nota è la fotografia del film, che con delicatezza e suggestione tenta di comporre un puzzle sociale della Cina di quegli anni
Con quest’ultima sceneggiatura Yan Geling conferma il suo talento nel padroneggiare metodologie e tematiche narrative diverse tra loro, rielaborando memorie personali e collettive in una ricca produzione letteraria amatissima dai lettori cinesi, nonostante faccia parte del gruppo di scrittori e scrittrici della diaspora che spesso riscuotono più successo tra il pubblico occidentale che cinese. La capacità di raccontare la propria storia e quella di un’intera generazione con uno sguardo intimo, ma diverso e rinnovato sulle pagine di un libro così come nelle scene del grande schermo, ha permesso a Yan Geling di ritagliarsi uno spazio ben definito nella scena creativa contemporanea cinese.