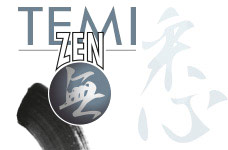Le mille storie di Mulan
La ragazza che salvò la Cina
Scritto da www.icooitalia.it - Uno dei temi più importanti e noti della tradizione cinese è indubbiamente la leggenda di Mulan, la più famosa eroina cinese, sospesa tra storia e leggenda, celebre e amata a livello mondiale, protagonista di ballate, poesie, filastrocche, novelle, romanzi, pièce teatrali, cartoni, fumetti, film, serie TV, in tutte le lingue del mondo.
Combattente intrepida, ragazza risoluta, figlia devota, fanciulla studiosa e ben educata, non esita a intraprendere le azioni più spericolate pur di compiere il suo dovere e difendere la sua famiglia e l’impero cinese minacciato da invasioni barbariche. Forte di una solida conoscenza dei testi classici confuciani e dei trattati di strategia, riesce a risolvere le situazioni più critiche e a prevalere su avversari molto più numerosi e forti, talvolta facendo anche ricorso alle arti magiche apprese con il nonno in un monastero taoista.
L’origine della leggenda si perde nella notte dei tempi. Per molti secoli, è stata tramandata in forma orale, sulla base di spunti probabilmente derivati da racconti cantati di epoca Han (206 a.C.-220 d.C.) e solo più tardi è stata trascritta. Successivamente è stata ripresa e rimaneggiata molte volte, sia in forma scritta sia, in tempi più recenti, in forma visuale. In tutte le versioni la trama di fondo è la stessa, ma si evidenziano numerosi cambiamenti e modifiche che rispecchiano essenzialmente usi, costumi, tradizioni e storia del periodo in cui sono state via via concepite e pubblicate le nuove versioni. La stessa tradizione orale, fin dalle origini, ha dato adito a variazioni sul tema e adattamenti alle diverse realtà locali che, come vedremo, si riverberano anche nella opere più recenti.
Il più antico documento scritto che tramanda la leggenda di Mulan è La ballata di Mulan (in cinese Mulan shi) contenuta nella “Collezione Ufficiale delle poesie”, compilata nel XII secolo dal letterato Guo Maoqian, nell’ambito dell’attività dell’ufficio imperiale preposto alla conservazione dei testi poetici. L’antologia comprende 5.290 componimenti del genere yuefu, cioè poesie con metrica irregolare perché destinate a essere cantate su basi musicali preesistenti, un genere che si è sviluppato in Cina a partire dalla dinastia Han (206 a. C. - 220 d.C.), ma che ha lontane radici nella poesia più antica. Il Bertuccioli (La letteratura cinese, Sansoni Accademia, Firenze 1968), inquadra invece La Ballata di Mulan nell’ambito della “poesia del Nord”, la forma di poesia popolare fiorita nel periodo di divisione della Cina (dopo la caduta della dinastia Han) appunto nelle regioni settentrionali, rimaste sotto il controllo di popolazioni non cinesi.
La prima versione scritta della Ballata di Mulan risalirebbe al VI secolo, durante la dinastia Wei (386-533) e la stesura sarebbe da attribuire al poeta e filosofo Liang Tao. Il condizionale è d’obbligo, perché non ci sono dati certi a questo proposito. Oggi, come si è detto, gli studiosi concordano solo sul fatto che la storia di Mulan ha origine in antiche narrazioni orali, rielaborate e riproposte in vari generi di letteratura popolare e che soltanto nel VI secolo è stata finalmente trascritta in forma ufficiale. Il testo, tuttavia, ha avuto vita travagliata poiché l’originale sarebbe andato perduto e sarebbe stato ricostruito sulla base di pochi frammenti per essere incluso nella “Collezione Ufficiale delle poesie”, dove lo possiamo leggere ancora oggi.
Nella stessa “Collezione Ufficiale delle poesie” si trova anche una versione più tarda della leggenda di Mulan. Si tratta di La canzone di Mulan di Wei Yuanfu, primo ministro durante la dinastia Tang (618-907), nell’VIII secolo. È la prima di una lunga serie di riproposizioni, rielaborazioni, variazioni sul tema che, attraverso i secoli, hanno arricchito la narrazione, introducendo di volta in volta modifiche strettamente connesse con l’evoluzione dei tempi, con i cambiamenti legati alla situazione sociopolitica del momento, con tradizioni e leggende locali, con espressioni della mutata sensibilità, con importazioni di influenze provenienti da altre tradizioni culturali, con fresche creazioni e ispirazioni dei singoli autori.
Il primo esempio eclatante è proposto proprio dalla Canzone di Mulan, che alludendo agli invasori contro cui combatte l’armata cinese di Mulan, sostituisce i nomadi Xiongnu, citati nella Ballata del VI secolo, con i Tibetani e altre popolazioni di origine turca loro alleate, storicamente temibili avversari della Cina nell’VIII secolo. Altre differenze possono essere rilevate nelle descrizioni degli abiti, del trucco e delle acconciature che Mulan adotta dopo il rientro a casa, per presentarsi agli ex commilitoni con la sua vera identità: semplicemente riflettono la moda e la foggia degli abiti del tempo in cui sono stati composti i testi.
Nell’impianto generale, invece, la Ballata e la Canzone differiscono poco una dall’altra: narrano la medesima vicenda, concentrandosi soprattutto sulla parte iniziale, quando la protagonista deve prendere la cruciale decisione di sostituirsi al padre arruolandosi in sua vece, e sull’epilogo, quando Mulan rientra in famiglia e la sua vera identità viene svelata. Entrambe le versioni sorvolano sulla parte centrale, la parte più epico-militare del racconto dedicata ai dodici anni di vita da soldato di Mulan, risolta in entrambi i casi con pochi accenni generici. I dettagli delle sue avventure, delle sue gesta, degli atti di eroismo compiuti devono essere dedotti da racconti popolari e leggende fioriti in singoli luoghi che, nella loro tradizione locale, vantano di essere stati teatro di alcuni avvenimenti che hanno visto protagonista la nostra eroina.
Dopo queste due celebri opere di poesia, non si hanno notizie della pubblicazione di ulteriori versioni scritte della leggenda fino al XVI secolo, durante la dinastia Ming (1368-1644), epoca a cui risale Mulan, la ragazza che si arruolò in vece del padre, del drammaturgo Xu Wei (1521-1593), che pare essere la più antica versione teatrale scritta delle avventure di Mulan. Per primo l’autore introduce la figura del bandito “Pelle di Leopardo”, inafferrabile capo carismatico di orde di ribelli, che Mulan riesce a intercettare e catturare. Si configura, quindi, uno scenario di rivolta interna o di guerra civile, più che di difesa da invasioni barbariche come nelle versioni più antiche; un contesto probabilmente più familiare e aderente alla realtà quotidiana del pubblico di epoca Ming.
Durante il regno della successiva dinastia Qing (1644-1911) si assiste a una vera e propria proliferazione di opere ispirate alla leggenda di Mulan, prima fra tutte Il romanzo dei Sui e dei Tang, di Chu Renhuo (n. 1635), un romanzo storico di cento capitoli, che riformula la leggenda ambientandola durante il periodo del declino della Dinastia Sui (581-618) e dell’ascesa della dinastia Tang. In quest’opera, la figura di Mulan è secondaria ed entra in scena solo nel capitolo 55; ma il finale è tragico: Mulan torna a casa, scopre che il padre nel frattempo è morto e che il khan la pretende nel suo harem. Piuttosto che cedere, Mulan si suicida.
Durante il regno dell’imperatore Qianlong (1736-1796), il principe mancese Yong’en (1727-1805) rimaneggia e sviluppa il dramma di Xu Wei, in una nuova opera teatrale dal titolo Una coppia di lepri. Qui la figura di Mulan è interpretata come un modello di lealtà alla dinastia regnante e viene introdotta la figura del fidanzato di Mulan che l’attende per tutti i dodici anni della sua impresa militare, fino al lieto fine del matrimonio tra i due, entrambi esempi di pietà filiale e fedeltà alle promesse e agli impegni presi.
Tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo ha molto successo l’opera in trentadue capitoli di un autore anonimo intitolata Storia della leale, filiale ed eroica Mulan. La vicenda è trasposta in epoca Tang, durante il regno dell’imperatore Taizong (r. 599-649) e ritrae una Mulan esperta in arti magiche e in segrete tecniche di combattimento, apprese dal nonno. Anche in questo caso la scelta dell’autore è per un finale drammatico con il suicidio di Mulan.
Nel 1850 viene pubblicato il romanzo in lingua volgare e in quarantasei capitoli Una storia straordinaria dei Wei del Nord: le imprese di una ragazza filiale ed eroica, di Zhang Xiaoxiang. Il romanzo unisce molte delle precedenti interpretazioni della storia di Mulan, sottolineando che la genialità e il coraggio di Mulan derivano dalla sua virtù. L’uscita del volume in stampa xilografica avviene in un periodo di crisi della dinastia mancese Qing, minacciata dalle interferenze sempre più pressanti delle potenze straniere e insidiata da malcontento e rivolte interne. Per questo l’autore enfatizza soprattutto il coraggio, la pietà filiale, la fedeltà all’impero e la lealtà dell’eroina, portata a modello di patriottismo per le giovani generazioni. Questa impostazione è ancor più evidente in una pièce teatrale intitolata semplicemente Hua Mulan, che il suo autore, Chen Xu (1879-1940), ha iniziato a far rappresentare sulle scene nel 1897, sebbene si debba attendere il 1914 per la prima edizione completa a stampa.
Ancora più numerose sono le variazioni sul tema introdotte dalle opere teatrali e cinematografiche che sono fiorite in gran numero a partire dall’inizio del XX secolo e fino a oggi.
La prima opera teatrale novecentesca in ordine di tempo è, probabilmente, Mulan si arruola nell’esercito: di autore anonimo, pubblicata nel 1903, è nello stile della tradizionale Opera di Pechino e ambienta la vicenda sotto il regno dell’imperatore Wudi (r. 140-87 a.C.) della dinastia Han. Pertanto, i nemici contro cui Mulan è inviata a combattere sono correttamente dal punto di vista storico i popoli Xiongnu. L’opera esalta, più che la pietà filiale, le virtù eroiche e patriottiche della protagonista, introducendo una chiave di lettura che per tutto il XX secolo sarà prevalente, come, in fondo, si confaceva a un periodo storico in cui la Cina e il suo popolo stavano affrontando una grave crisi politico-economica e sociale, per superare la quale era richiesto uno sforzo coeso ed eroico da parte di tutti i cittadini, comprese le ragazze. Nel 1917 (l’impero è ormai crollato ed è stata fondata la Repubblica Cinese, ma disordini e guerra civile turbano ancora la vita della Cina) il celeberrimo attore e autore teatrale Mei Lanfang (1894-1962), vera gloria del teatro cinese, noto in tutto il mondo, specializzato nell’interpretazione dei ruoli femminili, porta sulle scene una nuova versione di Mulan si arruola nell’esercito, sempre attenendosi ai canoni tradizionali. Mei spinge fino alle estreme conseguenze la trasformazione della figura di Mulan da devota fanciulla animata solo dalla confuciana virtù della pietà filiale, a eroica e coraggiosa ragazza ardente di patriottismo.
L’industria cinematografica cinese, animata da un crescente nazionalismo, negli anni Venti e Trenta del Novecento ha prodotto diversi adattamenti cinematografici della storia; il più riuscito porta lo stesso titolo dell’opera teatrale – in inglese Mulan Joins the Army – ed è uscito nel 1939. La casa di produzione è la Shanghai’s Xinhua Film Company. L’autore della sceneggiatura, Ouyang Yuqian, consapevole che il film sarebbe uscito in un momento difficilissimo per la Repubblica Cinese, lacerata dal contrasto tra Nazionalisti e Comunisti e devastata dall’invasione giapponese, si focalizza sull’eroismo della protagonista e sul patriottismo che la spinge a sacrificare tutto per la salvezza del Paese. Non mancano, tuttavia - tanto nel racconto di gesta eroiche, quanto nei momenti di civetteria e di allusioni sentimentali tra Mulan e il suo compagno d’arme Li - passaggi di vera e propria commedia, funzionali a mascherare la sottotraccia di allegoria politica che percorre tutto il film.
Un altro film di grande successo nelle sale cinesi e non solo, è Mulan: Rise of a Warrior (Mulan, l’ascesa di un guerriero) del 2009, diretto dal regista hongkonghese Jingle Ma e interpretato dall’attrice Zhao Wei, che ha avuto un ottimo successo commerciale e critiche positive a livello internazionale. Introduce nella vicenda molte varianti, nuovi personaggi, avvenimenti e imprese nuove, attingendo, ancora una volta a racconti di cantastorie ed episodi di storia locale.
Tutto ciò ha fornito e continua a fornire ispirazione per opere teatrali e musicali, novelle, libri per bambini, fumetti, cartoni animati, film e serie TV, fino ad arrivare al lungometraggio di animazione Disney del 1998 e al live-action della stessa Disney del 2020.
Questa affascinante vicenda, per così dire “editoriale”, della storia di Mulan, è stata parzialmente oggetto di un interessante studio di S. Kwa, W.L. Idema, intitolato Mulan, Five Versions of a Classic Chinese Legend with Related Texts (Hackett Publishing Company, Inc., Indianapolis-Cambridge 2010).
Con un taglio decisamente narrativo, invece, io stessa, in Mulan. La ragazza che salvò la Cina (Luni Editrice, Milano 2023), ripartendo dalla ballata originale, ho sviluppato i suggerimenti più significativi contenuti nelle più antiche versioni, confrontando vecchi testi cinesi con le interpretazioni otto-novecentesche, per riscrivere la storia di Mulan, evidenziandone i variegati momenti più avventurosi e coinvolgenti. Non volendo lasciar cadere nessuno dei filoni narrativi, talvolta non facilmente conciliabili tra loro, il volume ricorre allo stratagemma di dare al lettore la possibilità di “passare” da un capitolo all’altro scegliendo, quasi come in un librogame, quale delle molte storie di Mulan preferisce seguire. Questa scelta editoriale ha il pregio di evidenziare ed esaltare le due chiavi di lettura che, nel corso dei secoli, si sono alternate e tutt’oggi si impongono: da un lato la Mulan modello di pietà filiale, confucianamente devota ai genitori, al punto da sacrificare tutta se stessa e la propria vita alla difesa dell’onore della famiglia; dall’altro lato la Mulan eroica, fulgido esempio di patriottismo e di devozione all’imperatore e alla nazione cinese.
Molti studiosi si sono interrogati e tuttora si interrogano sulla reale esistenza di Mulan, senza pervenire a una risposta condivisa. La stessa frequenza con cui nelle leggende e storie locali compaiono figure di eroine e di ragazze combattenti indurrebbe a ritenere che nella realtà ci siano stati episodi bellici che hanno avuto per protagoniste ragazze in armi e forse Mulan ne è un’ideale sintesi. Documenti storici – e in particolare cronache di storia locale di alcune regioni settentrionali – sembrano suffragare l’ipotesi che siano effettivamente esistite figure di donne guerriere o, comunque, di donne che hanno affiancato il loro uomini nella difesa armata del territorio da invasori o da predoni. Ma le loro identità non sono state mai chiarite né valorizzate e si è preferito lasciare queste figure di guerriere avvolte nell’ombra del dubbio o della leggenda, rispecchiando la prassi imposta dall’ideologia confuciana alla quale ovviamente dovevano attenersi gli storici ufficiali incaricati di registrare fatti e avvenimenti per gli Annali imperiali di ogni dinastia.
Volendo ricordare una rara figura tramandata dalla storiografia ufficiale, si potrebbe citare l’esempio di Fu Hao, vissuta intorno al 1250 a.C. (dinastia Shang), moglie del re Wu Ding, la quale fu generale in capo dell’esercito del consorte. La sua sepoltura, rinvenuta nel corso di scavi archeologici nel 1976 a Yin Xu, vicino ad Anyang, con un ricco corredo di armi e asce da battaglia, ha attestato definitivamente il suo valore come guerriera.
Un altro esempio storicamente attestato è quello di Lu Mu, vissuta durante la dinastia Han: guidò la rivolta contro l’usurpatore Wang Mang (45 a.C. – 23 d.C.) che, fondando la dinastia Xin, aveva detronizzato Han. L’azione di Lu Mu contribuì a ristabilire l’ordine.
Si potrebbe ricordare anche Zheng Shi, moglie del potente pirata Zheng Yi (1765-1807) che comandava un’intera flotta di 200 giunche e 150mila pirati. Alla morte del marito subentrò nel comando della flotta ed è tutt’ora ricordata come uno dei personaggi più influenti nella storia della pirateria mondiale. Il film Cantando dietro i paraventi di Ermanno Olmi del 2003 si ispira alle gesta di Zheng Shi, che compare anche in Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo del 2007.