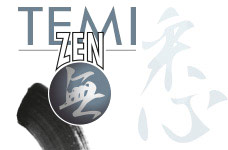L'Arte della guerra
Sun Zi Wu 孫子武
Scritto da www.nuinui.it - Sun Zi Wu 孫子武 era originario dello stato di Qi. La sua Arte della guerra fu notata da Helü 闔廬 re di Wu 吳, il quale gli disse: ‘Ho letto attentamente i 13 capitoli che hai scritto. Posso mettere alla prova la tua teoria sul modo di comandare i soldati?’. Sunzi rispose: ‘Sì, puoi’.
Inizia così la biografia di Maestro Sun – «Sunzi», appunto – riportata nel capitolo 65 dello Shiji (Memorie di uno storico) da Sima Qian (145-86 a.C.), considerato il primo storiografo cinese.
Questo riferimento sembrerebbe dunque avvalorare la storicità della figura di Sun Wu, leggendario personaggio la cui esistenza viene collocata dalla tradizione verso la fine del periodo delle Primavere e Autunni (770-453 a.C.): a lui è attribuita la paternità del Sunzi bingfa, ovvero «L’arte della guerra del Maestro Sun», testo chiave del pensiero strategico cinese. L’opera si articola in 13 capitoli (pian) che compongono un quadro completo della teoria della guerra – ma anche della pace – secondo il Maestro in questione. Studi recenti hanno però sollevato legittimi dubbi riguardo a chi ne sia realmente l’autore e il mistero che aleggia intorno a questa figura continua ad alimentare una discussione vivace. Si suppone che questo antico trattato militare, risalente con ogni probabilità al periodo degli Stati Combattenti (453-221 a.C.), non sia opera di un singolo pensatore bensì il frutto di una progressiva integrazione di testi relativamente indipendenti, che acquisiscono una forma coerente e unitaria intorno al IV secolo a.C.: una sorta di «scuola» composta da allievi e successori che si ispirerebbero agli insegnamenti di un saggio ed esperto stratega vissuto circa un secolo prima, cosa del resto non nuova nell’antica Cina e che caratterizza non pochi dei testi ascritti dalla tradizione ai vari Maestri.
A complicare ulteriormente il quadro concorre la figura di Sun Bin, citato anch’egli come «Sunzi» e autore di un bingfa (trattato militare) che si pensava perduto. Le due opere, il Sunzi bingfa e il Sun Bin bingfa, «L’arte della guerra di Sun Bin», sono state a lungo confuse, ma alcuni manoscritti scoperti nel 1972 a Yinqueshan (nella provincia dello Shandong) hanno confermato che si tratta di due testi distinti.
In definitiva, chiunque sia stato questo «Maestro Sun» (sempre che sia davvero esistito), importa ben poco. Ciò che conta è che il Sunzi bingfa è una sintesi mirabile del pensiero strategico elaborato in ambienti militari e politici fra i più sofisticati della Cina antica. E non è solo un trattato sulla guerra, ma un documento sulle strategie del potere, una guida su come «vincere senza combattere» in ogni ambito di contesa: dopo l’iniziale affermazione che l’arte della guerra sia di vitale importanza per lo stato, l’opera teorizza infatti che l’eccellenza suprema consista nello spezzare la resistenza del nemico senza combattere. Fra gli insegnamenti fondamentali, c’è quello di fare un uso sapiente e misurato delle proprie energie, sfruttando sia le potenziali dinamiche insite in ogni situazione per trarne il massimo profitto sia i punti deboli dell’avversario, dopo averne attentamente studiato il comportamento. Come nelle arti marziali, il segreto è trasformare lo slancio del nemico a proprio vantaggio, invece di lottare contro di esso. Il primato è conferito non alla forza bruta ma all’intelligenza strategica e alla pianificazione, con una chiara superiorità dell’inganno e dell’astuzia rispetto al combattimento diretto.
Il Sunzi bingfa occupa da secoli una posizione centrale tanto nella cultura strategica della Cina quanto nell’immaginario collettivo globale, e la sua influenza va ben oltre il contesto cinese, che pure vede tra i suoi estimatori personaggi del calibro di Mao Zedong e Chiang Kai-shek. La sua fortuna non si limita all’ambito dell’arte militare, ma attraversa epoche, culture e discipline, suscitando l’interesse di lettori e studiosi di ogni parte del mondo. Sintesi mirabile di nozioni e consigli, astuzie e stratagemmi per prevalere sull’avversario, questo classico stabilisce le regole della competizione, i metodi per affrontare conflitti e decisioni strategiche; insegnamenti incredibilmente attuali anche oggi e dalle innumerevoli applicazioni in tanti ambiti diversi da quello militare, dalla diplomazia all’economia, dal business al commercio. Dalla seconda metà del XX secolo, infatti, questo testo acquisisce notorietà come manuale di strategia aziendale, negoziazione e management, venendo però spesso decontestualizzato e ridotto a mera raccolta di aforismi.
In Giappone, dove viene tradotto da monaci buddhisti già in epoca Tang (618-907) e poi Song (960-1279), è letto e apprezzato fin dall’VIII secolo. In età moderna lo studiano strateghi, generali e militari giapponesi, nonché coreani. La notorietà in Occidente, invece, è piuttosto tardiva. Eppure, nell’arco di poco più di tre secoli, questo trattato riesce ad esercitare un fascino potente su grandi personaggi storici, rivoluzionari e leader politici di tutto il mondo.

La prima versione in una lingua occidentale compare nel 1772 (e viene poi ripubblicata nel 1782) con il titolo Les Treize Articles [de Sun Tzu] a firma di un missionario gesuita, Jean Joseph-Marie Amiot (1718-1793); si dice che anche Napoleone ne possieda una copia. Ciò che Amiot consegna al lettore occidentale, tuttavia, è solo un tenue riflesso del testo originale, con non pochi fraintendimenti, anche perché egli traduce a partire da una versione del XVIII secolo in mancese, la lingua ufficiale dell’impero Qing. In effetti, la prima traduzione francese dal cinese classico è probabilmente quella del 1988 a cura di Valérie Niquet.
Dopo il tentativo di Padre Amiot, passerà oltre un secolo prima che qualcuno osi davvero misurarsi con l’originale cinese. Nel 1905, a Tōkyō, appare una versione inglese parziale a cura di un ufficiale britannico, il capitano Everard Ferguson Calthrop. Questo primo tentativo è infarcito di «nipponismi» e debitore dell’aiuto di due studiosi giapponesi. Tre anni dopo Calthrop dà alle stampe un’edizione riveduta e corretta, ma le lacune restano: i passaggi più ardui vengono semplificati, allusioni e sfumature vanno perse.
La prima traduzione completa dal cinese classico in una lingua occidentale arriva a stretto giro ed è quella realizzata in inglese nel 1910 da Lionel Giles (1875-1958). Rispetto ad altre versioni più divulgative, questa persegue con rigore filologico e sobrietà d’intenti una resa più fedele all’originale e si distingue per il taglio accademico e la completezza del corredo critico. L’opera di Giles, su cui si basa l’edizione illustrata con 24 pagine a colori pubblicata da NuiNui nel 2024, presenta il testo cinese completo e uno straordinario apparato di note, spesso corredate da lunghe citazioni in lingua classica, riferimenti tratti dalla storia e dalla letteratura cinese, commenti, annotazioni puntuali e ricchi approfondimenti che si devono all’enorme cultura del curatore e alla sua incredibile capacità di penetrare anche nelle più recondite pieghe di significato del testo.
Sono tanti gli episodi storici su cui Giles si diffonde con dovizia di particolari nelle sue note, come quando nel capitolo I riferisce che Cao Cao (155-220) – celebre stratega, letterato e uomo di stato degli Han Orientali (25-220) – era talmente rispettoso della disciplina da condannarsi a morte da sé per aver lasciato che il suo cavallo scartasse in un campo di grano, infrangendo le regole da lui emanate a tutela delle coltivazioni; fu poi convinto a soddisfare il suo senso di giustizia tagliandosi semplicemente i capelli. Il racconto si deve a Du Mu (803-852), uno degli undici principali esegeti del testo di Maestro Sun, tra i quali si segnala per attendibilità e prestigio lo stesso Cao Cao.
Non pochi sono i riferimenti alla letteratura e proprio Cao Cao (citato anche come Cao Gong nella sua veste di commentatore e noto con il nome postumo di Wei Wudi, «Imperatore Wu di Wei») ci offre un commento al Sunzi bingfa esemplare per austerità e concisione, degno di un letterato di valore, ma chiaramente frutto delle raffinate conoscenze in ambito strategico del severo comandante che la storia ci ha tramandato. La sua biografia nel Sanguozhi (Cronache dei tre regni) – ci dice Giles – si legge come un vero romanzo; e sarà proprio quell’antico testo a ispirare uno dei quattro grandi romanzi classici della letteratura cinese, il Sanguo yanyi (Il romanzo dei Tre Regni, XIV secolo). Nella breve prefazione scritta per la propria edizione del Sunzi bingfa, in cui ripercorre alcuni dei passi sulla guerra più significativi della letteratura antica – dal Lunyu (Dialoghi) allo Shujing (Libro dei documenti), dall’Yijing (Libro dei mutamenti) allo Shijing (Libro delle odi) –, Cao Cao afferma che «chi si affida unicamente alla guerra sarà annientato; chi si affida unicamente alla pace è destinato a perire. […] Nelle questioni militari il Saggio si attiene normalmente alla regola di serbare la pace e muovere le sue forze solo se l’occasione lo richiede. Non userà la forza armata a meno di esservi costretto dalla necessità».
Nel capitolo VII, Giles fa riferimento a una storia mirabolante sul coraggio e le risorse di Cao Cao: nel 198 d.C. stava stringendo d’assedio il generale Zhang Xiu nella città di Rang, quando Liu Biao inviò rinforzi con l’intenzione di tagliargli la ritirata. Cao fu costretto a ritirare le truppe, ma finì per trovarsi chiuso fra due nemici che controllavano gli sbocchi di un valico angusto in cui si era infilato. Preso in una situazione così spinosa, Cao aspettò che calasse la notte, scavò un tunnel nel fianco della montagna e preparò un’imboscata al suo interno; poi continuò la marcia con il convoglio di carri. Quando schiarì, Zhang Xiu scoprì che l’uccellino si era involato e si affrettò a inseguirlo, ma, non appena tutto il suo esercito fu transitato, le truppe nascoste assalirono la retroguardia e Cao compì un’inversione di marcia per scontrarsi frontalmente con gli inseguitori, gettandoli nello scompiglio e annientandoli. In seguito, Cao Cao disse: «Quei masnadieri hanno provato a mettere in scacco il mio esercito mentre si ritirava, portandomi a combattere in una posizione disperata: per questo ho saputo come sopraffarli».
Rifacendosi a un altro degli undici commentatori, Li Quan (VIII secolo), nel capitolo III Giles prende a esempio un personaggio storico meno noto ma ugualmente efficace nell’esemplificare il famoso detto che recita «se conosci il nemico e conosci te stesso, non devi temere il risultato di cento battaglie. Se conosci te stesso ma non il nemico, per ogni vittoria che ottieni subirai anche una sconfitta. Se non conosci né te stesso né il nemico, perderai tutte le battaglie»: si tratta di Fu Jian (337-385), sovrano dei Qin Anteriori (351-394), che nell’anno 383 marciò con un grande esercito contro l’impero dei Jin Orientali (317-420). Quando gli fu raccomandato di non sottovalutare un nemico che aveva al proprio servizio uomini di grande valore, rispose arrogante: «Alle mie spalle c’è la popolazione di otto province, fanti e cavalieri che ammontano a un milione di uomini; ma come? quale pericolo dovrei temere […] ?». Nell’autunno di quell’anno, però, nella battaglia del fiume Fei, le forze di Fu Jian subirono una disastrosa disfatta e furono messe in rotta, costringendo il comandante a una ignominiosa ritirata.
Nel capitolo IX, per rievocare un’altra famosa battaglia combattuta su un fiume – la grande vittoria di Han Xin (?-196 a.C.) su Long Ju (?-204 a.C.) al fiume Wei nel 204 a.C. – viene citato il Qian Hanshu (Libro degli Han anteriori, capitolo 34), uno dei classici della letteratura storiografica cinese, che così descrive la battaglia: «I due eserciti si fermarono sulle sponde opposte di un fiume. Durante la notte Han Xin ordinò ai propri uomini di riempire di sabbia una decina di migliaia di sacchi e di erigere con essi una diga leggermente più a monte. Poi fece attraversare il fiume a metà dell’esercito e attaccò Long Ju, ma dopo un certo tempo finse di aver fallito il tentativo e si ritirò in fretta sull’altra sponda. Long Ju, felicissimo di questo successo imprevisto, esclamò: ‘Sapevo che in realtà Han Xin era un codardo!’. Poi si lanciò all’inseguimento, iniziando a propria volta a guadare il fiume. A quel punto Han Xin mandò una squadra ad aprire la diga di sacchi di sabbia, liberando una valanga d’acqua che spazzò via la maggior parte dell’esercito di Long Ju impedendogli di guadagnare la riva. Poi si rivolse contro le truppe che erano rimaste tagliate fuori e le annientò, e lo stesso Long Ju si contò fra i caduti. Anche il resto dell’esercito, sulla sponda opposta, si disperse e fuggì per ogni dove».

Nel capitolo V, parlando della necessità di mascherare la forza con la debolezza, Giles riporta un aneddoto citato da Zhang Yu, uno degli undici esegeti, vissuto in epoca Song. Riguarda una figura importante della storia cinese, quella di Gaozu (r. 206-195 a.C.), primo imperatore della dinastia degli Han Occidentali (206 a.C.-9 d.C.), che per debellare definitivamente gli Xiongnu – popolazione nomade dell’Asia centrale riunita in una potente confederazione tribale – inviò delle spie presso i nemici. Questi, essendo stati preavvertiti, nascosero tutti gli uomini validi e i cavalli pasciuti, lasciando visibili soltanto soldati infermi e bestiame emaciato. Avvenne così che tutte le spie raccomandarono all’imperatore di sferrare l’attacco. Solo un tale Lou Jing le confutò, dicendo: «Quando vanno in guerra, due nazioni sono portate per natura a dare grandi dimostrazioni di forza. Eppure, le nostre spie non hanno visto altro che vecchiaia e malattia. È senz’altro un trucco del nemico e per noi sarebbe avventato attaccare». L’imperatore però non tenne conto del suo consiglio e cadde in trappola a Baideng, presso Datong, nell’odierna provincia settentrionale dello Shanxi.
Nello stesso capitolo, si accenna alla possibilità di manipolare il nemico e determinarne i movimenti mandando segnali che ne indirizzino la volontà. Il già citato Shiji, sempre nel capitolo 65, riporta un aneddoto attribuito a Sun Bin: nel 341 a.C., essendo in guerra con Wei, lo stato di Qi inviò Tian Ji e lo stesso Sun Bin contro il generale Pang Juan, che era anche nemico giurato di quest’ultimo. Disse Sun Bin: «Lo stato di Qi ha fama di codardia, dunque l’avversario ci disprezza. Volgiamo questa circostanza a nostro favore». Così, quando l’esercito passò il confine del territorio di Wei, Sun Bin ordinò di lasciare visibili 100.000 falò durante la prima notte, 50.000 la notte seguente e solo 20.000 la notte successiva. Pang Juan si lanciò all’inseguimento, dicendo a sé stesso: «Sapevo che quelli di Qi sono codardi: si sono già più che dimezzati». Durante la ritirata Sun Bin giunse a una stretta gola che, secondo i suoi calcoli, gli inseguitori avrebbero raggiunto dopo il tramonto. Lì fece scortecciare un albero e scrivere su di esso: «Sotto quest’albero Pang Juan perirà». Poi, al calar delle tenebre, fece appostare un folto gruppo di arcieri nei pressi, con l’ordine di tirare direttamente nel punto in cui avessero visto una luce. Più tardi Pang Juan arrivò sul posto, notò l’albero e piantò una torcia per leggere quanto vi era scritto. All’istante fu crivellato di frecce e tutto il suo esercito cadde nella confusione. Questa è la versione della storia offerta dal commentatore Du Mu; lo Shiji, meno teatrale ma probabilmente più fedele al vero, fa suicidare Pang Juan, che si taglia la gola con un grido di disperazione alla vista dell’esercito in rotta.
Restando sempre in tema di manipolazione, nel capitolo VI vengono forniti utili consigli per impedire al nemico di ingaggiare battaglia quando non si desidera combattere, facendo ricorso a qualche strano e imprevedibile stratagemma che disorienti l’avversario. Giles si rifà ancora al commentario di Du Mu che riferisce di tre aneddoti esemplari, uno dei quali ha per protagonista Zhuge Liang (181-234), primo ministro di Shu durante il periodo dei Tre Regni (220-280), considerato uno dei più dotati strateghi del suo tempo. Mentre occupava Yangping e stava per essere attaccato da Sima Yi (179-251), generale del regno Cao-Wei, all’improvviso ammainò le bandiere, smise di far rullare i tamburi e fece spalancare le porte della città, lasciando in vista solo qualche uomo impegnato a spazzare o annaffiare la terra. Questo modo di fare inaudito ebbe l’effetto voluto, poiché Sima Yi, sospettando un’imboscata, richiamò effettivamente il suo esercito e si ritirò. Ciò che qui si raccomanda è, né più né meno, l’uso tempestivo del bluff.
Fra i tanti e spesso curiosi approfondimenti di cui è infarcita l’opera di Giles, troviamo interessanti commenti riferiti ad aspetti delle operazioni militari più strettamente tecnici: trattando dei carri da guerra (alcuni veloci e di struttura più leggera, altri più pesanti), per esempio, Giles rende il tutto più intrigante sottolineando le analogie con gli usi dei greci dei tempi di Omero: in entrambi i casi il carro da guerra era il fattore determinante, poiché formava il nucleo attorno al quale si radunava un certo numero di fanti appiedati. Quanto alle cifre fornite riguardo agli antichi cinesi, sappiamo che ogni carro veloce era scortato da 75 fanti e ogni carro pesante da 25, così che tutto l’esercito era diviso in un migliaio di battaglioni, ciascuno dei quali costituito da due carri e 100 uomini (capitolo II).

Nell’introduzione e poi per tutto il corso dell’opera, il curatore non nasconde la propria severità di giudizio e non esita a criticare duramente le traduzioni precedenti, accusandole di omissioni, travisamenti più o meno intenzionali e distorsioni di passi difficili. I commenti più pungenti, spesso non privi di una certa ironia, li riserva allo sventurato capitano Calthrop, vittima prediletta dei suoi strali, accusato delle peggiori «nefandezze», almeno nell’ottica di un sinologo come Giles, che affronta le questioni filologiche legate alla trasmissione degli antichi testi cinesi con lo stesso rigore che riserverebbe a una qualsiasi edizione di un classico greco o latino, nella quale errori del genere sarebbero inaccettabili. Secondo lui, le traduzioni dal cinese dovrebbero sottostare agli stessi standard di accuratezza e integrità riservati ai classici occidentali, meritando tutto il rispetto che la Cina, nel tempo, ha offerto grazie a secoli di commentari, esegesi, revisioni e quant’altro. È una questione di rispetto per il testo, rispetto che l’Occidente – troppo spesso preda del fascino per l’esotico e in balia di traduttori improvvisati – non sempre ha saputo garantire alla letteratura cinese e orientale in genere.

Lionel si distingue anche per la sua capacità di cogliere, da vero umanista, tutta la finezza e la complessità della scrittura cinese, e per la sensibilità con cui accompagna il lettore a riscoprire le interpretazioni degli antichi commentatori. Inoltre, con grande maestria riesce a creare intrecci e collegamenti tra la cultura militare cinese e quella occidentale, con riferimenti a vari personaggi della storia europea e americana, da Napoleone a Wellington, da Turenne al generale confederato Stonewall Jackson. Egli va costantemente alla ricerca di connessioni con l’attualità, come quando interpreta il pensiero di Sunzi alla luce dello scoutismo di Robert Baden-Powell, inteso come forma moderna di preparazione militare, o rievoca eventi ancora vivi nella memoria dei lettori, quali l’assedio delle legazioni a Pechino (1900) o un episodio dell’allora recente seconda Guerra anglo-boera (1899-1902).
Come ogni opera di traduzione, anche questa di Giles è a suo modo una scommessa, una sfida che va oltre le barriere della lingua e del tempo, e che si spera restituisca tutto il fascino e la ricchezza di questo classico.