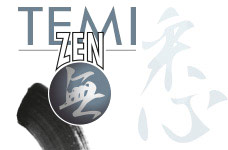Il viaggio in Manciuria di Natsume Sōseki
Scritto da -Nel 1909 Natsume Sōseki (1867-1916) ha quarantadue anni ed è ormai uno scrittore di successo noto al grande pubblico soprattutto per romanzi quali Wagahai wa neko dearu (Io sono un gatto, 1905), Bocchan (Il signorino, 1906) e Sanshirō (Sanshirō, 1908). Il 3 settembre dello stesso anno si imbarca sul piroscafo Tetsureimaru diretto in Cina e questo viaggio, insieme a quello di studio in Inghilterra tra l’ottobre del 1900 e il gennaio del 1903, sarà l’unico altro che egli farà al di fuori del Giappone nel corso della sua vita.
Sōseki sbarca a Dalian, che all’epoca i giapponesi chiamavano Dairen, e da questa città sita all’estremità della penisola del Liaodong, inizia un tour di sei settimane durante il quale visita importanti centri urbani collegati dalle linee ferroviarie gestite direttamente o indirettamente dai giapponesi: Lüshun, Shenyang, Fushun, Changchun, Harbin, Pyongyang e Seoul.
Il viaggio, sponsorizzato e spesato dalla Compagnia Ferroviaria della Manciuria meridionale,1 il cui presidente Nakamura Yoshikoto era amico di infanzia di Sōseki, rappresenta per lo scrittore l’occasione per visitare luoghi a lui sconosciuti e garantisce una certa pubblicità alla Compagnia che può legare il proprio nome a quello dell’ospite illustre.2
Sōseki parte per interesse e curiosità personali, ma con la consapevolezza che la sua visita, su invito del presidente Nakamura, potrebbe essere strumentalizzata per mostrare il sostegno dell’élite culturale alla politica estera giapponese. Del resto, nelle primissime pagine del resoconto di viaggio che Sōseki redigerà al suo rientro, Nakamura esorta l’amico a partire, proprio perché vuole che quelli come lui, gli intellettuali che parlano senza sapere nulla, vadano a vedere con i loro occhi cosa i giapponesi stanno effettivamente facendo nel continente.3
È bene ricordare infatti che il viaggio di Sōseki si svolge in un momento storico complesso. Le vittorie giapponesi sulla Cina (1894-1895) e sulla Russia (1904-1905) non solo hanno rafforzato a livello internazionale l’immagine del Giappone come potenza emergente in Asia, ma hanno portato all’acquisizione di territori importanti, sia da un punto di vista economico, per le risorse agricole e minerarie, che strategico-militare. Centrale in questo contesto è il ruolo della Compagnia Ferroviaria della Manciuria meridionale che, lungi dall’essere una semplice compagnia di trasporto civile, è a tutti gli effetti «un’organizzazione commerciale parastatale»4 che garantì al Giappone un avamposto in terra mancese e fu il principale strumento del colonialismo giapponese nella regione.
Durante il suo viaggio, Sōseki incontrò i dirigenti della Mantetsu, ritrovò vecchi amici e fece nuove conoscenze. Visitò impianti di lavorazione della soia, centrali elettriche e centri di ricerca gestiti dai giapponesi, ma anche località termali e siti di interesse culturale. Essendo alloggiato in alberghi lussuosi e trattato con ogni riguardo, il viaggio fu un'esperienza molto diversa da quella vissuta anni prima a Londra, dove si era sentito solo e spaesato, anche perché la misera borsa di studio del governo giapponese non gli consentiva di vivere decorosamente.
Il racconto di questo viaggio in Manciuria e Corea fu pubblicato da Sōseki a puntate sul quotidiano Asahi tra il 21 ottobre e il 31 dicembre 1909 con il titolo Mankan tokorodokoro (Qui e là in Manciuria e Corea). Titolo che suggerisce l’idea di una raccolta di impressioni estemporanee piuttosto che quella di un resoconto puntuale di ogni tappa dell’itinerario. La serializzazione fu però interrotta bruscamente con un’ultima nota dell’autore che laconicamente afferma: «Avrei altro da scrivere, ma mi fermo qui». Non si conoscono le reali motivazioni ma questo non è l’unico caso in cui Sōseki chiude in modo sbrigativo un’opera che sente di aver sviluppato a sufficienza.5
È probabile però che il repentino mutamento del clima politico possa aver influito sulla decisione. Il 26 ottobre 1909 infatti, l’ex primo ministro giapponese e residente generale in Corea, Itō Hirobumi, fu assassinato da un nazionalista coreano alla stazione di Harbin. La morte di Itō suscitò indignazione nell’opinione pubblica giapponese e portò alla pubblicazione di articoli tutt’altro che lusinghieri nei confronti dei coreani.6
Le contingenze potrebbero dunque aver reso difficoltoso continuare il progetto parlando proprio della Corea. In effetti, in una lettera datata 6 novembre 1909 indirizzata all’amico giornalista Ikebe Sanzan, Sōseki esprime le sue perplessità sulla continuazione dell’opera, adducendo come ragioni i recenti fatti di cronaca e la sua mancanza di voglia. Scrive infatti: «Grazie al suo consiglio, mi ero impegnato a proseguire nella scrittura di Mankan tokorodokoro, ma con la morte del principe Itō, l’arrivo del generale Kitchener, i funerali di stato e le grandi manovre militari, non so quando ci sarà spazio sulla terza pagina. I lettori si stanno dimenticando del mio racconto e io sto perdendo la motivazione. Ho sottomano ancora due o tre episodi da pubblicare, dopodiché le chiederei di poter terminare».7 Così, nonostante il titolo includa anche la Corea, di questa non si parla e la pubblicazione si conclude con il racconto della discesa in una miniera nel distretto carbonifero di Fushun in Manciuria.
Per altro, l’impressione generale che si ha leggendo Qui e là in Manciura e Corea è che Sōseki non fosse del tutto a proprio agio nel raccontare questo viaggio, soprattutto nei suoi momenti più ufficiali, e abbia cercato di cautelarsi da possibili critiche glissando su molti aspetti o toccandoli solo di sfuggita con una serie di espedienti.
Innanzitutto la narrazione è affidata alla voce di uno scrittore, che però non coincide del tutto con l’autore. Questo alter ego letterario è impacciato, spesso sorprendentemente ingenuo e smemorato, anche se molto ironico verso se stesso e gli altri. La scelta di un simile io narrante e la vena umoristica di molti episodi sembrano voler indurre il lettore a non prendere troppo sul serio quello che legge.
Inoltre il narratore non si mostra particolarmente interessato ad approfondire la conoscenza delle attività della Compagnia. In più di un’occasione cerca infatti di spostare il racconto su sensazioni o vicende personali che poco o nulla c’entrano con il contesto della visita. In effetti si potrebbe quasi affermare che i veri protagonisti dell’opera siano i ricorrenti attacchi di mal di stomaco e i ricordi di gioventù del narratore.
Gli attacchi di gastrite rendono particolarmente penosi i suoi spostamenti su carri e risciò e lo obbligano spesso a rimanere da solo in albergo. Sono però anche l’alibi a cui far ricorso per sottrarsi a impegni non graditi. Gli forniscono infatti una giustificazione per evitare escursioni che ritiene poco interessanti, per declinare inviti a tenere conferenze e per disertare balli o serate mondane in compagnia di personalità locali, dirigenti della Compagnia e funzionari stranieri residenti in Manciuria. Che Sōseki soffrisse davvero durante il viaggio è certo, ma nella trasposizione letteraria di quell’esperienza il mal di stomaco sembra essere un diversivo per tralasciare quel che non trovava interessante o non voleva raccontare.
Gli incontri con tre amici di vecchia data - Nakamura Yoshikoto, Hashimoto Sagorō e Satō Tomokuma, giunti in Manciura per ragioni diverse, sono invece l’occasione per aprire lunghi flashback sulla vita del protagonista e dei suoi compagni di scuola ai tempi delle superiori. Egli descrive con umorismo la scapestrataggine del gruppetto, insiste sul loro scarso rendimento scolastico, ricorda i viaggi in compagnia, le marachelle combinate, ma anche le manifestazioni reciproche di ammirazione, solidarietà e affetto. Secondo la studiosa Angela Yiu questi excursus non sono da intendersi come l’espressione di una generica nostalgia per gli anni spensierati della giovinezza, quanto del bisogno di celebrare un elemento di grande valore per lo scrittore: i legami profondi di amicizia costruiti in un contesto di interazione omosociale.8 E il viaggio, proprio perché offre l’opportunità rara e dunque preziosa di ritrovarsi insieme ai compagni di un tempo, permette di rinsaldare quell’amicizia rinverdendo i ricordi, chiacchierando o dedicandosi ad attività ricreative.
È dunque evidente come Qui e là in Manciura e Corea non sia un reportage giornalistico sulle attività della Compagnia, né tanto meno un resoconto puntuale del viaggio.
Dopo aver lasciato Dalian e Lüshun dove si concentrano la maggior parte degli impianti e delle infrastrutture realizzate dalla Compagnia, il narratore si sofferma a descrivere maggiormente gli scenari naturali, per lo più osservati dal finestrino del treno, o siti di interesse artistico e culturale, come le tombe imperiali di Beiling. In generale lo colpiscono l’estensione delle praterie e dei campi coltivati, la profondità del cielo mancese, la luce, il colore giallo della terra e anche l’aspetto bizzarro dei maiali locali. Può capitare che una scena gli ricordi un passo di un testo classico della letteratura cinese che tanto amava, oppure che accosti uno scorcio naturale a un dipinto a lui famigliare.
Problematico è invece il rapporto del protagonista con i locali. Egli non ha occasione di incontrare cinesi di alta estrazione sociale o di confrontarsi con intellettuali, interagisce per lo più con personale di servizio, cocchieri e portatori di risciò. Spesso si limita a osservarli all’opera e solo raramente ricorre alla guida locale o all’interprete per fare domande. In generale, eccezion fatta per qualche commento positivo sulla loro laboriosità, Sōseki si riferisce a loro chiamandoli coolies o chan, appellativi con una connotazione dispregiativa, e ne fornisce un ritratto piuttosto negativo insistendo soprattutto sulla loro sporcizia, sui modi bruschi e sul loro essere rumorosi.9
In merito a questa rappresentazione dei cinesi Joshua Fogel ritiene che Sōseki semplicemente non fosse in grado di trascendere i pregiudizi del suo tempo così come non lo era, per esempio, lo scrittore Evelyn Waugh (1903-1966) nei suoi racconti di viaggio.10 D’altra parte va ricordato che il politicamente corretto non esisteva all’epoca e che non solo i cinesi, ma anche gli altri occidentali incontrati durante il viaggio sono spesso oggetto di critiche. Ciò rivela una difficoltà nel rapportarsi con lo straniero, di qualunque nazionalità esso sia, proprio non solo del narratore, ma anche del Giappone dei primi del Novecento.
In definitiva Qui e là in Manciuria e Corea racconta forse più della sensibilità e dell’umore del protagonista che non dei luoghi in cui viaggia. Nondimeno offre una rappresentazione realistica della Manciuria e la decisione di interrompere la pubblicazione riflette le difficoltà di navigare tra esperienze personali e pressioni politiche, in un periodo di cambiamenti profondi per il Giappone e l'Asia.
Note
1. In giapponese Minami Manshū Tetsudō Kabushiki-gaisha, abbreviato in Mantetsu ↩︎
2. Sōseki non fu l’unico a ricevere l’invito da parte della Compagnia. Quando la scrittrice Yosano Akiko (1878-1942) era all'apice della sua carriera, lei e il marito ricevettero dalla Mantetsu l'offerta di sponsorizzazione del loro viaggio attraverso la Manciuria e la Mongolia. La coppia accettò e il viaggio fu completamente finanziato dalla Compagnia. La loro partenza per la Manciuria nella primavera del 1928 fu ampiamente pubblicizzata in tutta la regione, come dimostra la straordinaria accoglienza che ricevettero un po' ovunque da parte dell’establishment giapponese. Il viaggio non fu però senza rischi e molte tappe vennero riprogrammate, perché l’espansione militare giapponese nella regione aveva portato a un esacerbarsi della tensione nelle relazioni sino-giapponesi. Del resoconto di viaggio è disponibile una traduzione inglese a cura di Joshua A. Fogel in Yosano Akiko, Travels in Manchuria and Mongolia: a feminist poet from Japan encounters prewar China, New York, Columbia University Press, 2001. ¶ ↩︎
3. Per la traduzione italiana e relativo commento si veda Natsume Sōseki, Qui e là in Manciuria e Corea, trad. e cura di M. Taddei, Torino: Lindau, 2023. Dell’opera esistono anche una traduzione commentata in francese e una inglese: Haltes en Mandcyourie et en Coree précédé de Textes Londoniens, traduit du japonais par Olivier Jamet et Elisabeth Suetsugu, La Quinzaine Litterarie et Louis Vuitton, Paris 1997, pp. 119-278, e Rediscovering Natsume Sōseki With the First English Translation of Travels in Manchuria and Korea. Celebrating the Centenary of Sōseki’s Arrival in England 1900-1902, introduction and translation by Inger S. Brodey and Sammy I. Tsunematsu, Peter Owen Publishers, London 2005. ↩︎
4. Rana Mitter, Lotta per la sopravvivenza. La guerra della Cina contro il Giappone 1937-1945, Einaudi, Torino 2019, p. 30. ↩︎
5. Nel finale de L’ereditarietà delle passioni (1906) il narratore ammette di essersi dilungato troppo nel raccontare la vicenda e di aver perduto la voglia di continuare per altre cinquanta pagine. Riassume brevemente quel che ancora avrebbe da dire e si congeda dal lettore. Per la traduzione italiana del racconto si veda, Natsume Sōseki, Racconti sospesi nel vuoto, a cura di A. Maurizi, M.Taddei, Roma: Asiasphere, 2020. ↩︎
6. Sulle pagine dello Asahi, lo stesso giornale che pubblicava Mankan tokorodokoro, fu pubblicato Osoroshii Chōsen (La spaventosa Corea), un reportage di viaggio del giornalista Shibukawa Genji che aveva viaggiato con Sōseki in Corea e presentava il paese e i suoi abitanti sotto la peggiore luce possibile. ↩︎
7. La lettera è riportata nella raccolta completa delle opere dell’autore, Sōseki zenshū, vol. 23, Iwanami Shoten, Tōkyō 1996, p. 298. ↩︎
8. Per un’analisi approfondita di questo chiave interpretativa si veda Angela Yiu, «Beach Boys in Manchuria: An Examination of Sōseki's Here and There in Manchuria and Korea, 1909», Review of Japanese Culture and Society, vol. 29, 2017, pp. 109-125. ↩︎
9. In generale la sporcizia e il caos sono elementi che si ritrovano in quasi tutte le descrizioni di contesti urbani in Cina da parte di viaggiatori giapponesi. ↩︎
10. Joshua Fogel, Between China and Japan: The Writings of Joshua Fogel, Brill, Leiden-Boston 2015, pp. 522-24. ↩︎