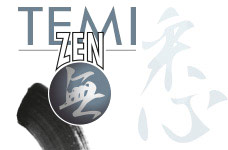Il Museo di arte bonsai di Ōmiya
Storia, capolavori, attività
Scritto da www.oltrelospazio.com - La pubblicazione di tutte le immagini di questo articolo è stata autorizzata dal Museo di Arte Bonsai di Ōmiya.
La magia della Natura che incontra l’Arte
Era il 1° settembre del 1923, quando la zona di Tōkyō e le regioni circostanti furono scosse da un forte terremoto accompagnato da incendi devastanti. È ricordato come il Grande Disastro del Kantō e fu proprio a causa della devastazione che ne seguì che un gruppo di professionisti del bonsai decise di lasciare Tōkyō e spostarsi verso la zona di Saitama, in cerca di un territorio favorevole alla creazione ed allo sviluppo dei bonsai.
Il Villaggio dei Bonsai di Ōmiya (Ōmiya Bonsai Mura) fu fondato nel 1925 e furono stabiliti quattro requisiti fondamentali per ottenervi la residenza:
- il possesso di 10 o più bonsai
- la disponibilità ad aprire il proprio giardino al pubblico
- costruire una casa di un solo piano
- delimitare la proprietà con siepi, evitando steccati e muretti.
Questo ha dato al villaggio un’atmosfera peculiare di tranquillità e pace, che si mantiene inalterata ancora oggi.
Molti giardini dedicati alla creazione e coltivazione dei bonsai sorsero nel villaggio e attualmente sei famiglie importanti portano avanti la propria tradizione e filosofia legata al bonsai, mettendo i propri giardini a disposizione dei visitatori per ammirarne i capolavori.
Sono:
- Shōsetsu-en (aperto nel 1977) di Teruo Kurosu, anche presidente della Fondazione per l’Arte Ceramica.
- Tōju-en (aperto nel 1931) di Hiromi Hamano, esperto in modo particolare di Pino bianco e bonsai shohin.
- Fuyō-en (aperto nel 1939) di Hiroshi Takeyama, esperto in modo particolare di caducifoglie e stili a bosco.
- Kyūka-en (aperto nel 1929) di Isamu Murata, che dedica una particolare attenzione alla potatura, perché l’effetto sia il più possibile naturale.
- Seikō-en (aperto nel 1943) di Tomio Yamada, porta avanti da generazioni l’eleganza e la bellezza della stagione e il fascino dell’arte di Edo.
- Mansei-en, il più antico, è il giardino della famiglia Kato, che qui si stabilì nel 1929 e che vanta una tradizione legata al bonsai di cinque generazioni (170 anni di storia). Il famoso Maestro Saburō Kato (1915-2008), rappresentante della terza generazione, offrì con il suo impegno un grande contributo allo sviluppo del Villaggio dei Bonsai di Ōmiya, come presidente della World Bonsai Friendship Federation e come presidente del comitato esecutivo del primo Congresso Mondiale del Bonsai.
Questo fu organizzato per la prima volta nel 1989 nella città di Ōmiya, oggi Saitama. Furono quattro giorni densi di dimostrazioni e laboratori di lavoro che rappresentarono un grosso successo di affluenza: 1200 amatori provenienti da 32 paesi diversi.
Prima di allora un evento significativo era stato rappresentato dall’Expo di Osaka del 1970, quando il governo giapponese propose tra le altre un’esposizione di bonsai e suiseki: la maggior parte dei bonsai esposti proveniva proprio dal Villaggio dei Bonsai di Ōmiya.
A distanza di ventotto anni dal primo Congresso Mondiale del Bonsai del 1989, si è tenuta nel 2017 l’ottava edizione: 120.000 visitatori da 40 paesi diversi!
Fu proprio la sempre maggiore crescita di interesse intorno all’arte bonsai al di fuori del Giappone a spingere i maestri delle grandi famiglie di professionisti del Villaggio del Bonsai di Ōmiya a pensare a nuovi strumenti per promuoverne l’attività.
Nel 2007 fu presentato un progetto per la realizzazione di un’istituzione pubblica che si occupasse dell’esposizione dei bonsai e mostrasse come prendersene cura, agendo anche come Museo per la ricerca sulla storia e la cultura del bonsai e del Villaggio dei Bonsai, oltre a promuoverlo. Il Museo fu inaugurato nel marzo del 2010 con l’obiettivo di fungere da portale di accesso alla cultura del bonsai e di promuovere il significato artistico e la storia del bonsai come parte della cultura giapponese tradizionale.
Di fronte all’ingresso si è accolti da un bonsai scelto per salutare i visitatori.
La visita inizia dalla galleria coperta, che comprende una parte didattica e una parte espositiva.
La parte didattica (foto sotto) presenta una serie di pannelli estremamente chiari e precisi, che spiegano:
- come apprezzare il bonsai, in altre parole quali elementi osservare per contemplarne la bellezza: le radici, la prima parte del tronco che si sviluppa dalle radici, la conicità del tronco e la sua corteccia, la ramificazione, il fogliame, la legna secca;
- le specie: conifere (shōhaku) e latifoglie (zōki);
- gli stili, o più precisamente le forme che gli alberi possono assumere in natura, sotto l’influenza dell’ambiente e delle sue condizioni peculiari;
- le tecniche che occorre applicare perché il bonsai si sviluppi in buona salute, mantenendo le sue piccole dimensioni pur sviluppando sempre di più le caratteristiche di un albero in natura verso la sua piena maturità, capace di muovere l’animo di chi lo osserva: annaffiatura, potatura, avvolgimento e trapianto.
La parte espositiva della galleria coperta propone cinque box (foto sotto) che reinterpretano in chiave moderna il ruolo del tokonoma. Ogni box rappresenta uno spazio espositivo elegante, ma sobrio, in cui l’esemplare esposto ha intorno a sé il giusto spazio e l’atmosfera ideale per esprimere al meglio la propria bellezza.
Gli esemplari esposti nei cinque box della galleria coperta vengono sostituiti di settimana in settimana e scelti secondo il focus del momento stagionale.
In certi momenti dell’anno vengono esposte altre opere d’arte legate alla sfera artistica del bonsai, come vasi, suiseki e piante erbacee.
Al termine della galleria espositiva la zona Zashiki-kazari comprende tre tokonoma tradizionali nei tre stili Shin, Gyō, Sō.
Il tokonoma Shin (foto sotto) ha il pilastro tokobashira in legno di cryptomeria, l’alzata bassa shimo-gamachi laccata nera, il piano in tatami con un bordo di disegno regolare e continuo (korai-beri). Vi trovano esposizione suiseki, incensieri e bonsai di raffinata eleganza. La stanza che presenta questo tipo di tokonoma è adatta ad accogliere ospiti di alto rango o status sociale e l’esposizione segue canoni piuttosto precisi, quindi si tratta di un’esposizione formale.
ll tokonoma Sō (foto sotto) nasce originariamente per la stanza del tè. Impiegando legni diversi per i pilastri e la cornice, tende ad annullare i confini dello spazio, pur limitato, della piccola casa del tè creando un’atmosfera naturale. Il piccolo daime-datami a sinistra del tokonoma è dedicato alla preparazione del tè. Si adattano alla collocazione in questo tokonoma i bonsai in stili più liberi ed informali, come il bunjin (stile dei letterati), per l’atmosfera peculiare che trasmettono.
Il tokonoma Gyō (foto sotto) non ha la formalità rigida dello stile Shin, né la libertà dai canoni offerta dallo stile Sō, ma si pone tra i due. All’atmosfera Gyō si adattano i bonsai a tronco sinuoso, le specie da fiore e frutto, gli alberi con una certa informalità.
Anche i bonsai esposti in questo spazio espositivo vengono sostituiti di settimana in settimana e scelti secondo il focus del momento stagionale.
Trattandosi dello spazio classico dedicato all’esposizione, i bonsai sono normalmente accompagnati da un rotolo dipinto appeso sullo sfondo del tokonoma e da un suiseki o da un’erbacea, che per le sue caratteristiche suggerisce il momento della stagione.
Da questa zona si esce nel giardino (foto sotto).
Il giardino accoglie in esposizione circa 60-70 esemplari, collocati in modo tale da poter essere contemplati da tutti i lati.
Il laghetto centrale offre umidità alle specie che prediligono un’atmosfera fresca e umida.
Un punto panoramico è rappresentato dal piccolo gazebo (Azumaya), ma una visione d’insieme del giardino si gode anche dall’alto, dal terrazzo al secondo piano dell’edificio principale, posto accanto alla sala conferenze.
Un particolare supporto girevole in pietra accoglie uno dei capolavori più grandi del museo, il Pino bianco giapponese Chiyō-no-matsu (Foto sotto).Nonostante le sue misure ragguardevoli (H160x180 cm, età stimata 500 anni), grazie a questo supporto l’albero può essere ruotato regolarmente in modo da ottimizzarne l’esposizione alla luce e garantire una crescita sana e uniforme da tutti i lati.
Dal giardino si accede alla sala espositiva che accoglie manifestazioni particolari, sempre a scopo divulgativo.
Gli esemplari della collezione del museo sono circa 160, dei quali 60 esposti a rotazione nell’area espositiva esterna e circa 7-10 nelle sale interne. Quando i capolavori non sono in esposizione sono collocati in una zona chiamata baiyōjō, o zona di coltivazione. Due artisti, formati da Maestri del Villaggio dei Bonsai, lavorano quotidianamente sui capolavori della collezione del Museo, ma altri artisti del villaggio partecipano a rotazione dando il loro supporto e mettendo a disposizione la propria esperienza (foto sotto).
L’estate è un momento critico per gli esemplari, poiché la temperatura può facilmente superare i 35-40°, quindi sono previste reti ombreggianti e gli artisti annaffiano fino a 3-4 volte al giorno. Il Giappone è anche battuto da tifoni, in estate, quindi tutti gli esemplari sono fissati ai propri supporti di legno (foto sotto).
In inverno, quando il clima si fa più rigido, può rendersi necessaria una copertura intorno ai vasi di molti esemplari durante la notte, per evitare che l’acqua all’interno possa gelare (foto sotto).
Se può capitare che un bonsai sia modificato nel corso della sua vita secondo la visione dell’artista che lo lavora, nel caso dei capolavori del Museo le tecniche di coltivazione tendono a mantenere ogni esemplare nella forma più vicina a quella con la quale è stato acquisito.
Il nome Higurashi significa “vivere la giornata” ed è stato dato a questo esemplare dal magnate Chutarō Nakano, che diceva di poter stare a guardare questo albero per un giorno intero senza stancarsi. La sua età stimata è di 450 anni.
Raccolto in natura e accudito da circa 90 anni mostra ancora la sua bellezza naturale.
Per quanto possa sembrare un doppio tronco si tratta di un tronco unico spaccato dalla base, che dà un fascino unico a questo esemplare. Il nome richiama l’immagine di una coppia di gru. La sua età stimata è di 300 anni.
Il tronco scavato, l’aspetto austero, il bianco della legna secca sono la giusta espressione del suo nome “Rombo di tuono”. La sua età stimata è di 1000 anni.
Il tronco imponente suggerisce il fascino di un albero maestoso. Lo stile è chiamato hōki-zukuri, forma a scopa. La sua età stimata è di 45 anni.
Fascino di questo esemplare sono il grosso tronco che ne mostra la maturità e lo splendido fogliame nei suoi cambiamenti stagionali. La sua età stimata è di 50 anni.
Un elemento di fascino di questo esemplare è il cosiddetto bankon, termine giapponese che indica una formazione di radici che richiama la roccia. La sua forma è stata creata per far sentire l’osservatore circondato da un paesaggio montano, durante una scampagnata. La sua età stimata è di 150 anni.
L’aspetto severo che suggerisce la corteccia fessurata che ne mostra l’età lascia il posto alla delicata, vivace bellezza durante la fioritura. La sua età stimata è di 80 anni.
L’obiettivo che ha spinto alla realizzazione del Museo sembra abbia trovato realizzazione. L’anno precedente alla pandemia da Covid 19 il Museo ha accolto 29.676 visitatori, di cui 6.720 stranieri. Il Museo ha aperto alle persone un portale di accesso alla cultura del bonsai. Ogni anno ospita gite scolastiche per oltre 30 scuole elementari e organizza regolarmente eventi per i bambini (foto sotto). Attraverso le sue attività, mostre e iniziative un numero sempre crescente di giovani hanno l’opportunità di entrare in contatto con l’arte tradizionale del bonsai.
Penso a quanti gruppi di turisti italiani ho accompagnato a visitare il Museo dei Bonsai di Omiya, una tappa immancabile nei miei itinerari di viaggio. Ricordo la diffidenza di alcuni, abituati a pensare al bonsai come ad una pianta moribonda schiacciata in mezzo a tante altre sullo scaffale di un supermercato o a una pianta dalla forma improbabile in vendita in un vivaio. E ricordo poi la loro ammirazione, fintanto la commozione nel contemplare il fascino di questi capolavori, nel comprendere quanto rispetto e quali attente cure siano dedicate a questi esemplari, in alcuni casi da generazioni.
Lo sguardo scivola lungo le curve del tronco, è catturato dalle fessure profonde, dall’eleganza delle ramificazioni, indugia sulla grazia dei fiori e poi torna a posarsi su quella base che racconta una storia… e l’anima torna a sentire quel senso di appartenenza alla Natura che a volte sembra dimenticato e si riempie di quell’energia che la Natura sempre offre, generosa.
Questa è la magia della Natura che incontra l’Arte.
Il Museo di Arte Bonsai di Ōmiya si trova a circa 35 minuti dalla stazione ferroviaria di Ueno (Tokyo) scendendo alla stazione di Toro e da qui è ben segnalato e raggiungibile a piedi in circa 10-15 minuti. Il signor Owada, dell’Ente di Promozione Turistica di Saitama, può organizzare una visita ai giardini dei Maestri del Villaggio del Bonsai e al Museo, in modo da poter usufruire di una visita guidata in inglese con il signor Turton, Coordinatore per le Relazioni Internazionali per il Museo.
Instagram: @omiyabonsaiartmuseum

Alessandra Bonecchi
Da sempre ammiro l'arte e la filosofia giapponese e studio le sfumature che il buddhismo zen ha donato alle variegate espressioni della cultura giapponese.
Dopo gli studi universitari di lingua e letteratura giapponese ho avuto l'opportunità di continuare a coltivare i miei interessi nella sfera lavorativa, traducendo una rivista giapponese e riadattandone i testi per la più importante rivista italiana sull'arte bonsai.
Ho tradotto alcuni libri sull'arte del suiseki, sul giardino giapponese e sullo zen e ho scritto diversi articoli dedicati al bonsai, al giardino giapponese, allo zen e agli alberi monumentali italiani censiti dal Corpo Forestale dello Stato.
Affiancando per oltre vent'anni un maestro giapponese di arte bonsai nei suoi corsi come interprete ed assistente ho apprezzato l'approccio orientale all'insegnamento e ho fatto tesoro di ogni suo messaggio.
Vent'anni fa ho avvicinato l'arte marziale del kung-fu, in particolare il tai-chi-chuan, affascinata dalle sue origini dal taoismo cinese e sono istruttrice e cintura nera di terzo grado.
Attraverso Oltre lo Spazio uso oggi il mio bagaglio di studio e di esperienza per un'attività più personalizzata, mirata a far stare bene le persone in momenti di aggregazione creativa, avvicinandole alla natura, all'arte, alle discipline che offrono benessere psico-fisico.
Mi affianca Alice, mia figlia, anima eclettica, creativa, dinamica, appassionata di arti marziali, musica, danza, viaggi. Porta i suoi studi e le sue esperienze a servizio di nuove idee e nuove collaborazioni, per portare avanti il nostro entusiasmo e i nostri valori.