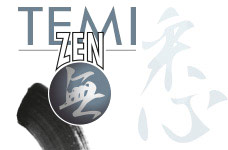Quando la passione non dà respiro
Storie d’amore e morte del teatro giapponese
Scritto da - Ohatsu e Tokubei s’incamminano lungo la via che porta al santuario di Sonezaki. Lui la conduce per mano in questo che è il loro addio al mondo, il loro addio alla notte: due esistenze labili come la brina che si dissolve a ogni passo, sogno di un sogno. Lei indossa il kimono candido di chi si consegna alla morte, e sopra un soprabito nero, come oscure sono le vie dell’amore.
«Hai contato i rintocchi della campana?» chiede Tokubei. «Dei sette che segnano l’alba, ne sono suonati sei. Il settimo sarà l’ultima eco che sentiremo in questa vita».
Un ultimo sguardo all’erba, agli alberi, al cielo. Le nubi, il fiume scorrono ignari di loro. Sull’acqua scintilla il chiaro riflesso delle stelle dell’Orsa. Se solo questa notte fosse un po’ più lunga… ma la spietata notte d’estate svanisce al canto del gallo, che affretta la sua ora. I due innamorati entrano nel bosco di Sonezaki, il cielo è scuro, il vento fermo. Si abbracciano stretti mescolando le lacrime, mentre si lasciano cadere al suolo. Tokubei affonda il pugnale, poi, quando vede Ohatsu accasciarsi, apre la mano: «Posso forse rimanere indietro? Esaleremo insieme l’ultimo respiro».1
Così suona – in una parafrasi che a dire il vero sintetizza parecchio l’originale – l’apice melodrammatico di Sonezaki shinjū (Suicidio d’amore a Sonezaki), forse la più nota e rappresentata di tutte le pièce che formano lo straordinario repertorio del teatro giapponese di epoca Edo. Chi ha visto Dolls, il capolavoro di Takeshi Kitano del 2002, può confermare quanto la poesia che scaturisce da un amore impossibile continui a esercitare un fascino potente al di là delle epoche. I due amanti di Kitano, figli del Giappone metropolitano, vestiti da Yōji Yamamoto, sono seguiti dalla telecamera in una fuga che ha la stessa cadenza di quella citata sopra. Il michiyuki – così si chiama tecnicamente questo viaggio finale in cui si coagula la tragedia – è quasi sempre presente nei drammi d’amore di Edo e rappresenta l’ultimo atto di un precipitare di eventi che prendono le mosse da molto distante.

Immagine tratta dal libro “Storie d'amore e morte del teatro giapponese” - Nuinui, 2024.
Ma cominciamo dal principio. Tutto parte da un fatto di cronaca reale: nel quarto mese del 1703, a Ōsaka, un giovane contabile di bottega, destinato a ereditare la redditizia impresa dello zio, e una cortigiana di una casa d’appuntamento vorrebbero coronare il loro amore con giuste nozze, ma le regole sociali non lo consentono. Lui è un ragazzo serio e posato, di buona famiglia, con un futuro dorato davanti a sé, lei una poco di buono, una reietta relegata negli spazi del piacere, dietro le porte scorrevoli di quelle che con pudore vengono chiamate case da tè. Due mondi opposti e complementari, il mondo diurno del lavoro, dell’accumulo, dei sacrifici – giri in giapponese – e quello notturno della trasgressione, della dissipazione, della passione – ninjō –, che nella rigida impalcatura confuciana possono convivere solo a prezzo di una inflessibile separazione.
I due giovani potrebbero forse lasciare tutto e cominciare una nuova vita insieme in un’altra città, ma oltre alle insormontabili difficoltà che questo comporterebbe per le leggi del periodo Edo, c’è una complicazione di tipo affettivo. Il ragazzo deve tutto allo zio, che l’ha adottato e che vorrebbe dargli in sposa la nipote. Come deluderlo? Come macchiarsi di una simile ingratitudine? Ai due innamorati non resta che la fuga. Non una fuga verso una nuova vita, ma una fuga verso il nulla. Vivere finalmente uniti, ma da clandestini, braccati nella propria terra, senza futuro. Che altro può esserci al termine di quel viaggio, se non la morte?
Il suicidio dei due amanti di Ōsaka sconvolse l’opinione pubblica, e già un mese dopo era pronto un libretto destinato al bunraku, il teatro delle marionette, che ne ripercorreva pari pari la vicenda, con l’unico accorgimento dei nomi cambiati. Ne era autore quello che si può a buon conto considerare il più grande drammaturgo del periodo Edo, Chikamatsu Monzaemon (1653-1724), che proprio nella scena della fuga scatenava il meglio della sua vena lirica. La rappresentazione riscosse un successo clamoroso e innescò un incredibile processo di emulazione. Solo in quell’anno, si verificarono almeno diciassette suicidi di coppia. In seguito, dall’opera venne tratta una versione live per il teatro kabuki, in tempi più recenti diverse riduzioni cinematografiche e da poco un adattamento per manga.

Immagine tratta dal libro “Storie d'amore e morte del teatro giapponese” - Nuinui, 2024.
Era il primo testo teatrale di ambientazione contemporanea e diede avvio a un intero filone, quello dei cosiddetti sewamono, che s’imponevano all’attenzione del pubblico con la forza dell’attualità. Attorno a uno schema di base più o meno costante, il librettista si sbizzarriva a imbastire ambientazioni sempre diverse, insaporendo il tutto con gli ingredienti classici del teatro popolare: inganni, tradimenti, rivalità, agnizioni, colpi di scena di ogni genere.
Se Meido no hikyaku (Corriere per l’inferno) del 1711 e Shinjūten no Amijima (Doppio suicidio ad Amijima) del 1721 riprendono quasi identica la traccia di Sonezaki, decisamente eccentrica è la scenografia di Hakata Kojorō del 1718, collocato nell’ambiente dei pirati che battevano i mari fra Giappone e Cina.

Immagine tratta dal libro “Storie d'amore e morte del teatro giapponese” - Nuinui, 2024.
In Yari no Gonza, del 1717, imprevedibilmente, lo scenario è quello della cerimonia del tè e delle varie scuole concorrenti che proliferavano in epoca Edo. Altrettanto imprevedibilmente, qui i due fuggitivi non sono due amanti, ma la moglie (fedele) di un maestro del tè e il suo discepolo prediletto (a sua volta regolarmente fidanzato), che per un malinteso vengono presi per adulteri, sono costretti a fuggire insieme e a quel punto…
Doppiamente pruriginosa è la materia di Shinjū mannensō (L’erba dei diecimila anni per un suicidio d’amore) del 1710, ambientato nel complesso templare del monte Kōya, fra le pratiche esoteriche della setta Shingon. Qui l’amante in fuga è nientemeno che un novizio vincolato alla carriera monastica. Deraglia invece dallo schema corrente Yaoya Oshichi, del 1706, ispirato al fatto reale di una ragazza di Edo che nel 1682, al fine di creare le condizioni per poter rivedere il suo innamorato, scatenò un incendio e venne perciò condannata a morte.2

Immagine tratta dal libro “Storie d'amore e morte del teatro giapponese” - Nuinui, 2024.
Insomma, i drammi che furoreggiavano nei teatri di Ōsaka e Edo, attraendo un pubblico enorme e facendo la fama degli attori più talentuosi, sono numerosi e multiformi, ma capaci nell’insieme di restituire un quadro piuttosto coerente della mentalità dell’epoca. A cominciare dalla tipologia dei personaggi. Con una certa sorpresa, scopriamo per esempio che il modello del giovane innamorato non è affatto quello del maschio muscoloso e volitivo che immagineremmo in una terra appena uscita da secoli di cultura samurai – quello è semmai il cattivo, di cui fornisce un eclatante esempio il pirata Kezori Kuemon di Hakata Kojorō, ruolo che rese celebre l’attore Danjurō VII e tutti i suoi discendenti.

Immagine tratta dal libro “Storie d'amore e morte del teatro giapponese” - Nuinui, 2024.
Le ragazze di Edo vagheggiavano piuttosto un delicato dandy lievemente effeminato, un animo sensibile e poetico, con un gusto raffinato nel vestire e l’ineluttabile tendenza a sognare a occhi aperti. Di certo un modello che arrivava da secoli remoti, da quel famoso principe Genji, poeta e donnaiolo, in cui Murasaki Shikibu aveva incarnato l’ideale delle dame di Heian.3 C’è un po’ di Genji in tutti i protagonisti di questi drammi, ma la reviviscenza più compiuta del principe è il languido e viziato Izaemon di Kuruwa bunshō (Lettere d’amore, 1808), che fra l’altro offre uno dei rarissimi lieti fini del repertorio.
Inutile dire che il corrispettivo femminile di questo tipo d’uomo difficilmente poteva essere incarnato dalla moglie dimessa e laboriosa che nel nuovo Giappone di mercanti e bottegai la famiglia avrebbe auspicato per il proprio rampollo. Gli uomini di Edo sognavano e idealizzavano, qualche volta perdendoci il senno, le fatali cortigiane delle case da tè, creature eteree e inaccessibili, fatte per offrire il piacere in tutte le sue sfumature, non toccate dalla polvere del mondo.
Alle altre, le prosaiche brave ragazze adibite alla figliolanza e alla conduzione della casa, non restava che assistere impotenti ai deliri passionali dei consorti, rassegnate all’angolo d’ombra che la saggezza confuciana aveva preparato per loro. Qualche volta, forse per l’educazione al sacrificio, la moglie arriva addirittura a collaborare come può alla realizzazione della felicità del marito con l’altra. È il caso di Shinjūten no Amijima, in cui Osan vende tutte le sue cose – compresi i kimono dei bambini – per riscattare la cortigiana amata dal consorte, o Nebiki no kadomatsu (I pini del Capodanno), in cui Okiku lascia partire di buon grado Yojibei con l’amante affinché si salvi dalla prigione: «La moglie innamorata, in lacrime, pensava che se il cielo fosse stato giusto, a lei sarebbe toccato di accompagnare il marito, ma così aveva voluto il suo destino, e così, mettendo a tacere la gelosia, le imponeva il suo affetto».4

Immagine tratta dal libro “Storie d'amore e morte del teatro giapponese” - Nuinui, 2024.
Va da sé che di queste abnegate mogliettine poi non si sappia più nulla. Il drammaturgo, dopo averci fatto piangere con la loro dedizione, immancabilmente se ne dimentica per tornare al tema più forte dei due amanti.
Specchio dei tempi, questi drammi d’amore ambientati nella contemporaneità svolsero un ruolo prezioso nel portare alla coscienza sociale nodi e contraddizioni di cui il sistema fingeva di non accorgersi. Il Giappone stava rapidamente cambiando e la vecchia morale cominciava ad andare stretta alle nuove generazioni. Il finale tragico di tante di queste storie sottolineava proprio l’inesorabile incompatibilità fra felicità del singolo e dovere sociale.
Note
1. Parafrasato da O. Civardi, Storie d’amore e morte del teatro giapponese, Nuinui, CH, 2024, pp. 16-19. ↩︎
2. Storia questa resa celebre, prima che dal teatro, da Ihara Saikaku, che già poco dopo i fatti la incluse nel suo Kōshoku gonin onna (Cinque donne amorose, 1686, trad. it. Lydia Origlia, a cura di G.C. Calza, Adelphi, Milano, 1980). ↩︎
3. Genji, il Principe Splendente, è il mai tramontato protagonista del Genji monogatari, il primo romanzo giapponese, scritto da Murasaki Shikibu nell’XI secolo (La storia di Genji, trad. it a cura di M.T. Orsi, Einaudi, Milano, 2015). ↩︎
4. O. Civardi, Storie d’amore e morte del teatro giapponese, Nuinui, CH, 2024, p. 105. ↩︎